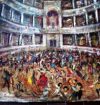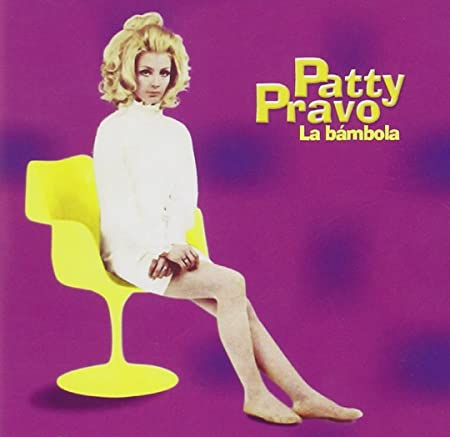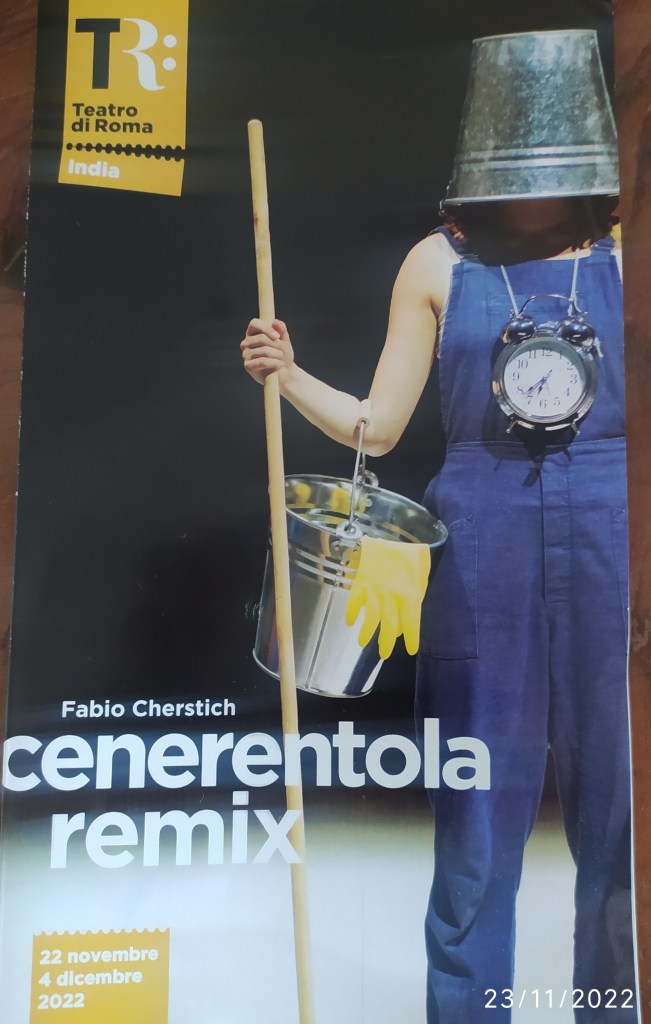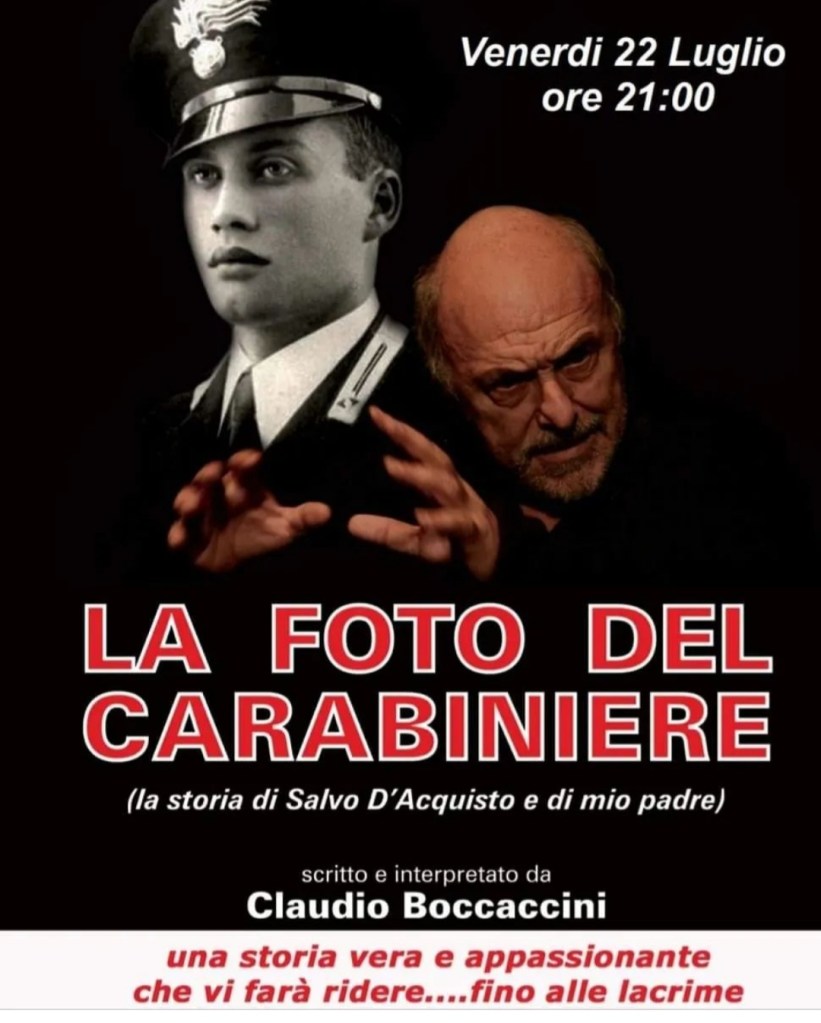TEATRO BELLI, 5 e 6 Aprile 2023

Sa già tutto: sa che si sta approssimando la sua fine; sa che scriveranno su di lui che è stato un poeta, alcuni; un idiota, gli altri. Sa che lo dipingeranno e lo riprodurranno su pietra.
Ma non sapeva quanto potesse essere straziantemente dolce essere un Uomo. E com’è bella la Terra; bella da morire. Per questo trova così difficile separarsi da tutto ciò.
Si tortura chiedendosi perché suo Padre non risponda al grido d’aiuto del Figlio. Ma soprattutto lo ossessiona il dubbio di chi sia lui ora. E se riuscirà, solo con le sue umane forze, ad essere all’altezza della situazione.

Giorgio Sales, in un momento delle prove dello spettacolo “Ricordate che eravate violini”
Questo è il Cristo che emerge dalla drammaturgia di sublime bellezza diretta da Francesco D’Alfonso: un Cristo che sente irresistibile l’esigenza di dedicare tutto il tempo che gli resta a meditare, a riflettere su ciò che ora lui è diventato, dopo questa esperienza di travolgente “umanità”.

Il musicista Lorenzo Sabene, il regista e drammaturgo Francesco D’Alfonso e l’attore Giorgio Sales
Perché restare presente a sé stesso, senza lasciarsi andare totalmente alla disperante angoscia dell’attesa, può aiutarlo a prendersi cura di sé stesso. Solo lui può farlo. Solo lui può dedicarsi quell’attenzione unica, speciale, che riuscirà a fargli sostenere il peso della disattenzione altrui.
È la sua, una meditazione notturna di rara bellezza: come può essere bello ciò che è umano, intriso contemporaneamente, cioè, di bene e di male.
Il Figlio fatto Uomo si cerca e “si legge” nelle ore della sua “passione”, quelle notturne – dal crepuscolo all’alba – attraverso le parole laiche di altri Uomini, che di lui parleranno. Poeti e scrittori come J.L. Borges, J. da Todi, K. Gibran, M. Luzi, A. Merini, E.E. Schmitt.
Prende vita così una consapevolezza filiale e umana che risplende di disperazione. Un Gesù che ha paura. Che non sa attendere. Che è divorato dall’ ansia: non ultima quella da prestazione. Che piange.
In una stanza. Senza riuscire a fare a meno di ascoltare musica: quella di J. S. Bach, di F. De Andrè, di J. Dowland, di S. Weiss, di S. Landi, di M. Lauridsen, di A. Piccinini, di M. Ravel e di F. Valdambrini. “Sepolto” sotto infiniti fogli: quelli dei libri che parleranno di lui. Senza smettere di cercarsi in uno specchio: e trovandoci, dentro, anche noi del pubblico.
Ma a lui non basta: avanza fin sulla ribalta per sentirci più vicini. Noi, invece, “la sua presa” vocale, la sentiamo ancor meglio del tatto. Più che se ci toccasse. Ci cattura: ci fa suoi; scaccia qualsiasi altro pensiero dalla nostra mente e dal nostro cuore. Esiste solo lui e ciascuno di noi. E la sua meditazione diventa anche la nostra.
Ha lo sguardo seducentemente duro, subdolo, avvelenato dall’angoscia. Non è il volto dei pittori. Ma si danna chiedendosi se ancora lo ameremo. Se lo invocheremo.
“Com’è forte la paura contro la grazia!”- si ripete.
E poi al Padre: “perché non intervieni ?” .
Abbandonato: “stordito da un assordante silenzio”.
E pensare che questo era il suo “sogno”: diventare “uomo” .
Ma com’è possibile che proprio un sogno l’abbia trascinato verso questa fine? Una fine che gli fa così paura? Com’è possibile essere traditi dalla legge? Com’è possibile essere traditi con un bacio?
La meditazione di Cristo prende avvio in simbiosi con la tonalità armonica minore dell’ammaliante accompagnamento musicale di Lorenzo Sabene, dove l’azione sinergica di liuto, torba e chitarra è insieme balsamo e graffio. Ma poi sale in un crescendo fino alla tonalità armonica maggiore. È un Cristo che s’affanna e ansima. Quasi come una belva. E anche noi del pubblico ci scopriamo a cambiare frequenza di respiro.

Lorenzo Sabene
Un Cristo-Uomo che perde la sua “centratura”, il suo equilibrio: accade al suo corpo ma anche alla parola, alla voce.
Arrivano i soldati: lo catturano, lo processano e lo crocifiggono.
E lì, sulla croce, il Figlio di Dio “sbiancò come un giglio”.
Lo depongono e lo coprono con un bianco sudario. Meravigliosa la coreografia di gesti fisici e vocali alla quale Giorgio Sales dà vita con questo velo bianco: quasi una danza con qualcosa che sembra ma non è. Ma a breve si rivelerà.
Complice di raffinata efficacia drammatica, un disegno luci attento e sapiente che ci accompagna, contrappuntisticamente, fino alla rinascita. Fino alla resurrezione.

Giorgio Sales, in un momento delle prove dello spettacolo “Ricordate che eravate violini”
Ma è un attimo. Il sipario si chiude e in noi resta più che la gioia, la voglia disperata di stare ancora con Lui nei momenti della “passione”. Forse perché ora, attraverso questa meditazione laicamente sacra nella quale siamo riusciti a sintonizzarci, abbiamo scoperto il desiderio e la capacità di essere presenti a noi stessi. Di osservare e di osservarci. Anche nel dolore.

Francesco D’Alfonso
Una splendida occasione di bellezza, ci offre questo spettacolo di Francesco D’Alfonso, rievocando la ciclicità visceralmente sacra degli indimenticabili giorni della Passione Cristo.
Due perle, i camei fuori campo di Roberta Azzarone e di Lorenzo Parrotto.
Giorgio Sales ci strazia. Ma non possiamo farne a meno. Riesce ad essere tutto e il contrario di tutto. Suo, è il profumo dell’attore.

Giorgio Sales
” Voi che siete oppressi ed esalti nel male,
ricordate che eravate violini
pronti a suonare le ragioni del mondo ”
(Alda Merini, Cantico dei Vangeli).