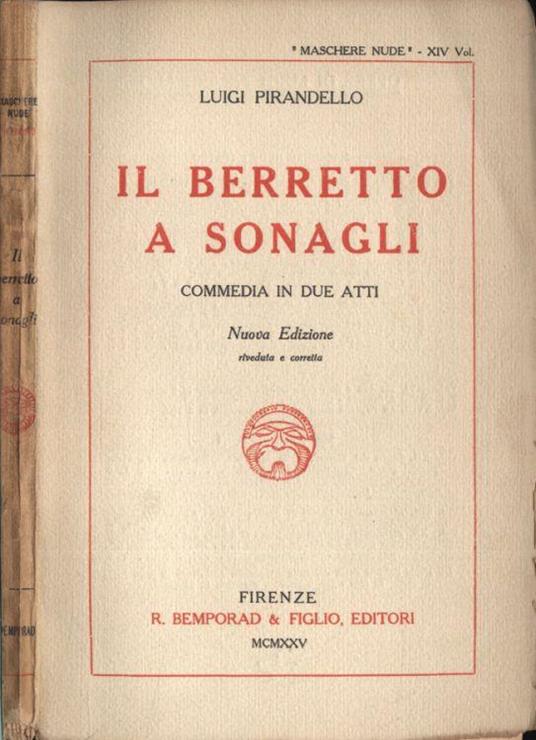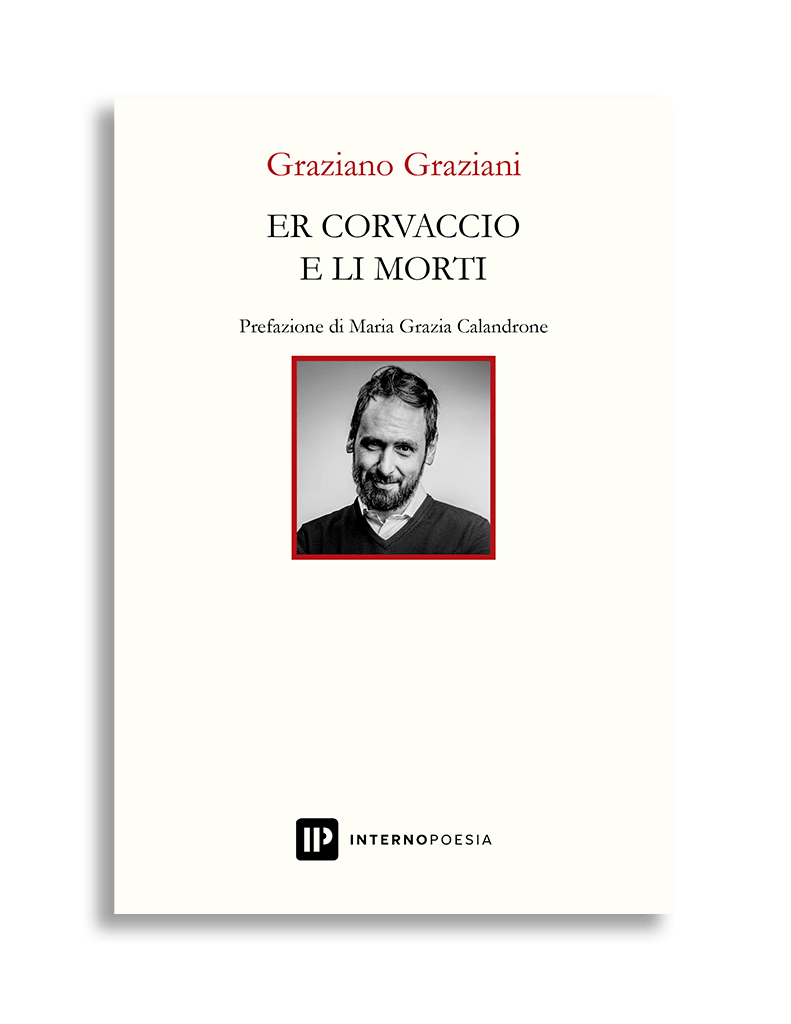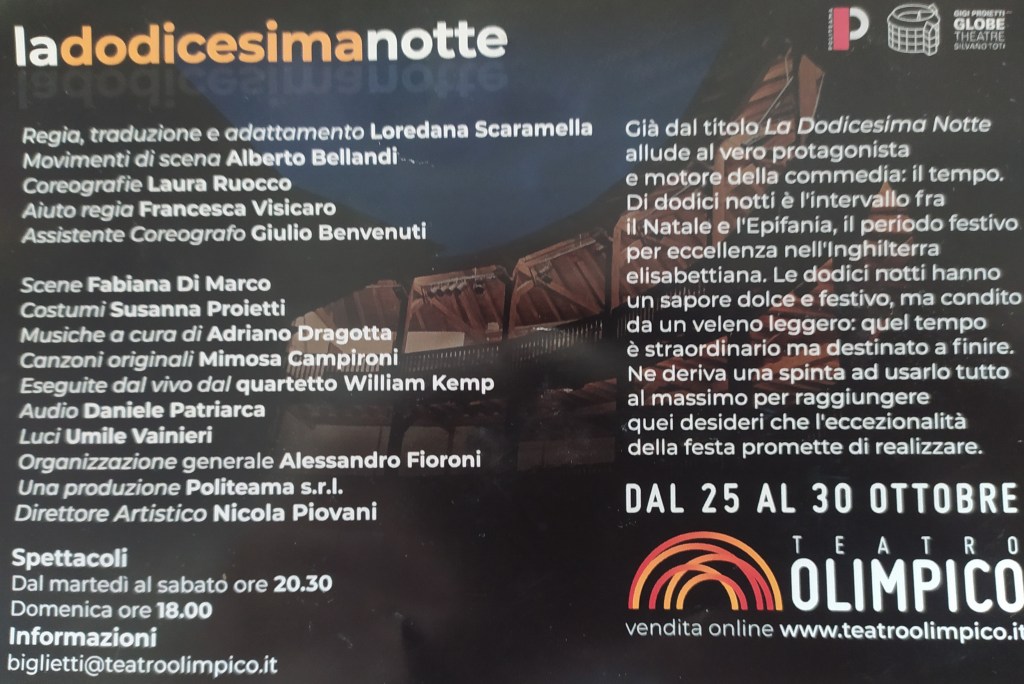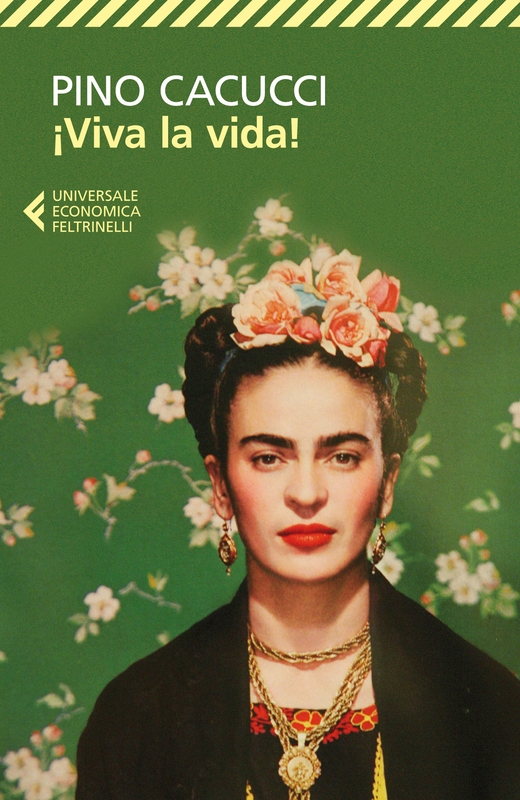TEATROSOPHIA, 11 – 13 novembre 2022 –

E’ in una stazione, luogo dove s’incontrano vite (e metafora della vita che, come un treno, sfreccia tra paure, sogni e desideri) che noi incontriamo Célestine (un’ammaliante e profonda Giovanna Lombardi).

Lei è (apparentemente) l’unica protagonista del “Diario licenzioso di una cameriera”: emozionante adattamento del regista Gianni De Feo della pièce del rinomato drammaturgo Mario Moretti, che a sua volta adattò dal testo originale di Octave Mirbeau “Journal d’une femme de chambre“.
Seduta, ma cangiante come i colori dei cieli dolci e piovosi della Normandia, Célestine aspetta di arrivare alla sua nuova destinazione lavorativa, al suo nuovo destino. È di una bellezza austera e sensuale: sembra uscita da un manifesto di Toulouse Lautrec (i costumi sono di Roberto Rinaldi).

Henri de Toulouse Lautrec, Divan Japonais – 1893-
Quando inizia a rivolgerci la parola siamo invasi dalla sua malizia. Ci arriva dalla sua voce golosa; dal suo corpo che si offre e si cela; dalla sua bocca così morbida e umida; dal suo tatto così avido di superfici da esporare.

Una scena del “Diario licenzioso di una cameriera ” di Gianni De Feo
E dai suoi gesti così in simbiosi con la musica. Ma sono i suoi occhi a stregarti e a portarti via con lei. Dovunque il suo capriccio decida di andare. Occhi che proiettano paure, eccitazioni, gioie. Occhi che sanno parlare anche in quei silenzi così potentemente densi. Nella malìa della sua narrazione, Célestine denuncia l’ipocrisia dei suoi datori di lavoro, appartenenti a quella borghesia che ostenta “case linde e pinte dietro facce disgustose”.

Una scena del “Diario licenzioso di una cameriera ” di Gianni De Feo
Lei presta servizio come cameriera e si descrive in una maniera che potrebbe farla risultare un’opportunista. Lo è. Anche. Ma non solo. Il suo non è un mero scambio di servizi. Lei “sa guardare”. Non solo con gli occhi ma anche con la mente. E con il cuore.

Una scena del “Diario licenzioso di una cameriera ” di Gianni De Feo
Ha la capacità di visualizzare anticipando gli eventi che la coinvolgono e poi la prontezza di sincronizzarvisi. Per questo quando ci parla degli uomini e delle donne che ha incontrato, lei “scatta” veri e propri “ritratti” umani. Non si accontenta di lavorare per vivere. Vuole “sentire”, piuttosto, cosa significa vivere. In quanti modi si può vivere. Quanto può essere seducentemente contraddittoria la vita.

Una scena del “Diario licenzioso di una cameriera ” di Gianni De Feo
Come può accadere di essere attratti dalla violenza che si mischia alla protezione e dalla malattia che è anche fonte zampillante di vita?
Eppure accade, se non ci si ferma sulla soglia delle ipocrite classificazioni borghesi. Perché se si ha davvero fame di vita, non si può non riconoscere che il bene non si dà mai disgiunto nettamente dal male. Giudicare non ha più senso, allora. E non è più vero, come aveva dichiarato inizialmente, che lei sia impenetrabile: che nulla la meravigli. Lei sa di essere “una donna che fa sangue”, che ha bisogno di sedurre e di essere sedotta. Sa che la sua luce è data dalle sue ombre e non teme di rivelarle, quando anche l’altro le fa dono di ciò che non ha.

Questo adattamento del “Diario licenzioso di una cameriera” di Gianni De Feo è uno spettacolo magnetico: un inaspettato viaggio emozionale . Merito di una regia curatissima, introspettiva e raffinatamente sfacciata. Le scene (di Roberto Rinaldi) sono semplici ma efficaci pennellate di ottimo gusto e il disegno luci, unito alla complicità delle scelte musicali, fonte diegetica: alcuni momenti sono costruiti su immagini scritte con la luce.