SUNDAY BOOGIE THEATER, 20 Febbraio 2022 –

Una serata dedicata ad Ettore Petrolini, genio “deformatore” del Teatro di Varietà, grazie ad un progetto trasversale alla multimedialità di Enoch Marrella.
Lo spettacolo si apre con un prologo musicale fuori campo, dove Petrolini (nelle vesti di Gastone una delle sue più riuscite creazioni) invita lo spettatore a non fermarsi alla superficie ma piuttosto ad ascoltare bene quello che c’è dentro, quello che c’è sotto.
“È il mio motto – dice Gastone – “sempre più dentro, sempre più sotto”.

Solo ora può prendere forma e fare il suo ingresso l’interprete: un profondo ed ipnotico Enoch Marrella in frac scuro, labbra scure, biacca e brillantina, dalla quale sfugge per un attimo un tirabaci. Un volto ed una voce metamorfici, accompagnati incantevolmente dalle note del Maestro Paolo Panfilo. La comicità irriverente erompe lasciando poi il passo a riflessioni più amare e compassionevoli sulle debolezze umane.
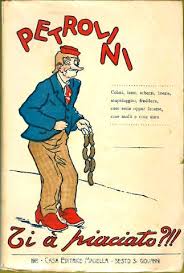
Si susseguono, secondo la moda futurista, versi malthusiani. Uno fra tutti:
Petrolini è quella cosa che ti burla in ton garbato, poi ti dice: ti à piaciato? Se ti offendi se ne freg.
Lui è il re dello sberleffo e della satira pungente e caustica con la quale condanna ipocrisia e malcostume. E non risparmia né popolani, né potenti.
È il dadaista Fortunello che – come disse lo stesso Marinetti – “scava dentro il pubblico tunnel spiralici di stupore e di allegria illogica e inesplicabile”.
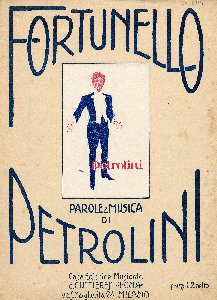
Sono un uom grazioso e bello
sono Fortunello.
Sono un uomo ardito e sano
sono un aeroplano.
Sono un uomo assai terribile
sono un dirigibile.
Sono un uomo che vado al culmine
sono un parafulmine.
E’ Salamini: una creazione spontanea e insieme elaborata, sciocca ma geniale, che racconta di “un imbecille di statura ciclopica”.

Ho comprato i salamini e me ne vanto
se qualcuno ci patisce che io canto
è inutile sparlar
è inutile ridir
sono un bel giovanottin
sono un augellin…
A seguire il raccontino di Isabella e Beniamino e subito dopo una veloce trasformazione: il frac lascia la scena ad una camicia e a delle bretelle che si sfidano sull’effetto optical, sublimate da una gorgiera bianca. Sui capelli impomatati cala il sipario di una parrucca nera dal taglio carrè con frangia. È il gran finale in cui Marrella/Petrolini, con il teschio di Yorick sotto braccio, interpreta “il pallido prence danese, che parla solo, che veste a nero”: Amleto.
Ma la singolare analisi della storia “deformata” da Petrolini, osa scioglier ogni dubbio:
Si può essere più afflitti, più lagnosi, più melanconici di Amleto?
Poteva essere felice, no!
Poteva essere amato, no!
Io non ho mai capito che cosa voleva Amleto.
Ma che voleva Amleto?
…
L’amore è facile
non è difficile
si ha da succedere
succederà.

Sulle note di questa ariosa conclusione anche il pubblico si unisce a cantare in coro, dopo l’invito di un insolito Amleto aperto alla condivisione.
Un lavoro interessante dove Enoch Marrella, complice il Maestro Panfilo, riesce a trascinare lo spettatore: divertendo ed emozionando.

Per maggiori informazioni su Enoch Marrella:
-Premio Tuttoteatro.com Dante Cappelletti 2021: vincitore con lo Studio “Tecnicismi”
-Spettacolo “Sottobanco” per la regia di Claudio Boccaccini










































