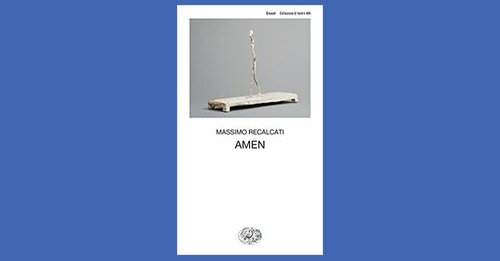PROGETTO ČECHOV
(Seconda tappa)
di Leonardo Lidi
TEATRO VASCELLO – dal 9 al 14 Aprile 2024

Cosa succede quando il passato invade il presente?
Quando i ricordi fagocitano gli impulsi creativi?
Succede che si riduce notevolmente la visione prospettica sulle nuove possibilità di “riempire gli anni”. Ieri come oggi.
La regia di Leonardo Lidi affida a Nicolas Bovey la cura per la realizzazione di un’efficacissima struttura scenografica capace di veicolare – già solo attraverso l’impatto visivo – la claustrofobia di questa perversa modalità di stare al mondo.

In verità questo possibile modo di vivere esprime la tensione più potente che abita la natura dell’essere umano. E non è quindi propria di un determinato periodo storico. Per natura infatti siamo tutti inclini a conservarci, a proteggerci dall’ignoto. A ridurre il nostro campo visivo e quindi il nostro campo d’azione. Preferiamo renderci innocui.
Ecco allora che il confine che separa il passato dal presente avanza smisuratamente appropriandosi di grand parte dello spazio d’azione. Anche sul palco. Ed è subito afa.
Ne deriva la sensazione di un presente schiacciato, opprimente, senza un fiato di vento. Dove ci si accontenta di anelare – attendendola più o meno compostamente tra richieste di compatimento e imbambolimento vario – l’azione rigenerante di un temporale.

Un presente “a campo corto”, dove si mangia e si dorme. Ma soprattutto dove si beve molta vodka: per acquisire – almeno per tutto il tempo della sbronza – “un simulacro di vita”. E così provare ad agire, ad osare. Perché tutto il resto, è noia.
Una noia che non è la serenità della pigrizia. Piuttosto la logica conseguenza emotiva di quel senso di disinteresse che non conosce uno sprone che punga, facendoci contorcere alla disperata ricerca di qualcosa di non monotono, di interessante. E’ quella noia che è la cifra di chi non immagina progetti, di chi non coltiva interessi di stupore partecipe.

Una noia piena di fiumi di parole che, sebbene scorrano via a ritmi vorticosamente accelerati, restano in bilico sul loro stesso valore logico. Di conseguenza anche quel che resta del sistema emotivo va in tilt. O si scolora. E assieme all’ habitus (il modo di fare, il costume sociale) perde vivacità anche la seconda pelle, ovvero l’abito, che non osa spingersi oltre le tenui tonalità pastello (la cura dei costumi e di Aurora Damanti).
Lidi sceglie allora che la recitazione degli attori incarni questo ondivago senso delle parole sia attraverso un’apparentemente solida immobilità del corpo, sia attraverso una totale rottura dei piani del corpo. Quasi burattini nelle mani del fato. Ed è bellezza.

Una bellezza che fiorisce da un lavoro attoriale che riesce ad esprimere l’urgenza simbiotica del corpo di “aderire” allo spazio. Di “spalmarsi” su di esso, lungo ogni coordinata. Un corpo quasi totalmente privo di autentici slanci d’entusiasmo, se non espressi con la complicità della vodka.
Ma che fine hanno fatto i desideri? Quella spinta, il desiderio, che regala così tanta tonicità alla psiche umana? In un habitat atarassico, dove si desidera solo l’autoconservazione, sono bandite le tensioni di qualsiasi natura. Troppo pericolose: sono fucina di cambiamenti. E i cambiamenti spaventano assai.

Ma la scelta di votarsi alla sicurezza di un male conosciuto piuttosto che a un bene tutto da scoprire risucchia linfa vitale: quella che spinge ad andare alla scoperta, alla ricerca. Anche della propria vocazione: anzi no, “quella la conosce solo Dio”.
E ci si chiede, fuori da ogni consapevolezza logica, se chi verrà dopo si ricorderà di loro come coloro che hanno “spianato la via”. Valore che Puskin riconosceva all’opera di Batjuskov, autore così amato dal Professor Serebrjakov. Ma per essere onorati dagli eredi occorre essere padri “interessanti”.
E poi ci si rammarica di invecchiare troppo velocemente. Ma come evitarlo se si vive all’insegna della monotonia: dove niente di quello che si fa è “interessante”? Dove niente è più capace di destare curiosità, di suscitare attenzione o partecipazione ? Dove niente coinvolge e appassiona? Neanche l’amore. Neppure quello per la natura. Perchè – come riconosce zio Vanya – “si vive di miraggi quando manca l’autentica vita”.

Tentazione così maledettamente vera anche oggi.
E pensare che quando scopriamo qualcosa che ci interessa scopriamo un legame, qualcosa che sta in mezzo e ci avvicina a qualcosa o a qualcuno. Perché l’interesse è la cifra dell’unione fra noi e tutto il mondo intorno. Ed è un invito alla partecipazione e al coinvolgimento.
Senza interesse ci si accontenta di vivere in una squallida torre d’avorio, capaci solo di osservazioni distanti e distorte, evitando di calarsi davvero nella realtà per rendersi nodo solido di una rete.
La regia di Leonardo Lidi affida allora a Franco Visioli la cura di creare sonorità labirintiche e lunari e a Nicolas Bovey una drammaturgia delle luci proveniente da un cielo basso e vagamente sinistro. Tali da enfatizzare la vacuità sterile delle crepe esistenziali dei personaggi, resi con sconcertante verità extratemporale dagli attori in scena. Si ride. Ma da qualche parte ci arriva una fitta.

Lidi sceglie – ed è la sua filosofia – un teatro di attori dove un desiderio collettivo risulti superiore ad un desiderio personale. E infatti Giordano Agrusta, Maurizio Cardillo, Ilaria Falini, Angela Malfitano, Francesca Mazza, Mario Pirrello, Tino Rossi, Massimiliano Speziani, Giuliana Vigogna splendono restituendoci l’agrodolce miseria dei loro personaggi, proprio in quanto consapevoli parti irrinunciabili di un tutto.
Leonardo Lidi ha un talento che brilla per la capacità di “tradire fedelmente” i testi del grande teatro classico. Il suo è un modo di gestire l’eredità dei padri del teatro che onora il valore di testimonianza. Un teatro, il suo, con una particolare raffinatezza di gusto: un teatro divertente che si guarda bene dall’essere “innocuo”.
Un teatro necessario.

Leonardo Lidi, il regista
“Zio Vanja” è la seconda tappa – dopo “Il Gabbiano” – del suo Progetto Cechov, prodotto da Teatro Stabile dell’Umbria, Teatro Stabile di Torino e Festival dei Due Mondi. La trilogia si completerà con “Il giardino dei ciliegi” che debutterà tra qualche mese al Festival dei Due Mondi di Spoleto.
Recensione di Sonia Remoli