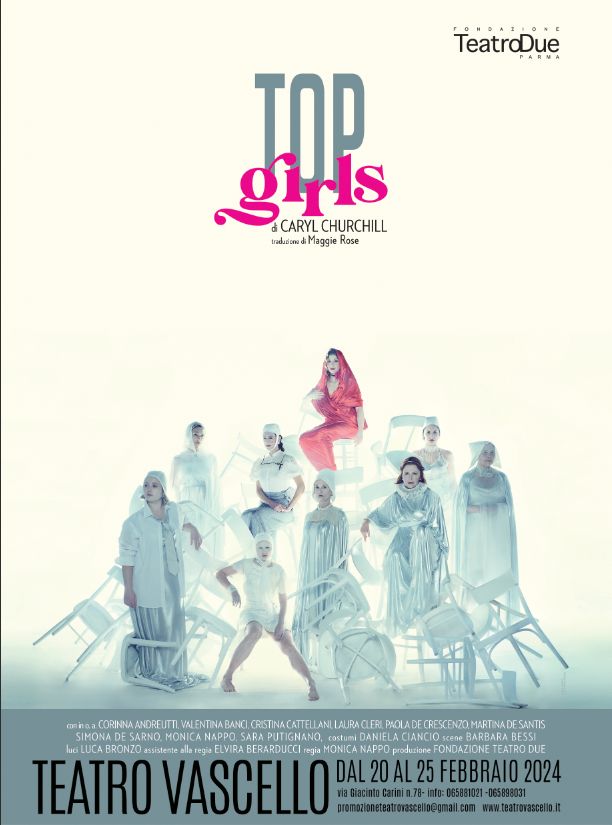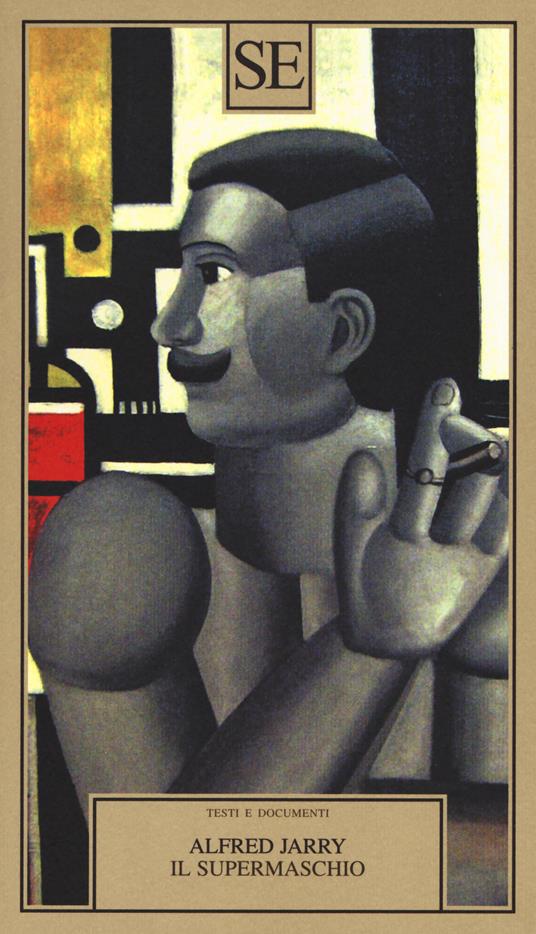TEATRO LE MASCHERE, dal 25 al 27 Giugno 20224

Quanto è difficile essere liberi ?
Quanto ci angoscia poter scegliere ?
Anzi, dover scegliere: anche scegliere di non scegliere è comunque una scelta.
La libertà è una condanna: siamo obbligati ad essere liberi – sosteneva Jean-Paul Sartre.
Meno male che c’è l’economia capitalistica.
Lei sì che ci legge nel pensiero: lei ci solleva dall’usare il cervello e quindi ci libera dalla libertà. E quanto ci piace ?!
Lei si assume tutte le responsabilità e noi ubbidiamo. Senza pensieri, senza dover usare con libero spirito critico la nostra capacità di pensare.
Come recita la filosofia del franchising dei negozi Primark: costa tutto così poco che non devi pensare a cosa scegliere. Puoi comprare tutto, ingordamente. Fino alla nausea. Fino alla morte.

Martina Gatto
Da qui prende avvio lo spettacolo, che ammicca alla stand-up comedy, diretto con sapiente minimalismo da Dafne Rubini e interpretato da un’esplosiva e penetrante Martina Gatto. La drammaturgia è di Claire Dowie, anche attrice e poetessa: sicuramente uno dei personaggi più divertenti, anticonformisti ed iconoclasti della scena teatrale inglese contemporanea.
Con provocante ingenuità Martina Gatto ci racconta di quel giorno in cui si accorge di non stare bene: non sente più l’istinto di andare a comprare qualcosa di nuovo, sintomo di una “sana e robusta costituzione” nella società consumistico-capitalistica in cui viviamo.
E sebbene, in verità, non avvesse bisogno di nulla, come si poteva resistere a non andare da Primark a comprare almeno una T-shirt, che generosamente avevano scontato a 2euro e 50 centesimi ?
Pur non avvertendo più la seduzione di questa opportunità, si sforza di andare comunque. Ma quelle luci così attraenti ora hanno perso il loro potere euforizzante, così irresistibilmente trendy. Quella scioglievolezza che normalmente le si iniziava a generare in bocca varcando le porte d’ingresso, ora le provoca terrore. E più entra all’interno più si sente morire, tanto il consueto piacere ha lasciato il posto a un disagio sempre più invadente.
Persa la dipendenza all’istinto compulsivo ad acquistare, tagliata fuori dallo spazio incantato del Primark, in quale altro modo sarebbe stata al mondo ?
In realtà, al di là dei confini del tempio del consumismo, lei farà esperienza di una nuova speciale sensazione: quella della mancanza, unica porta d’ingresso ad un autentico desiderare. Non a caso i genitori del dio Eros – ci racconta Platone ne “Il Simposio” – erano Penia (che significa “mancanza”) e Soros (“la via”). La via della mancanza genera eros: il desiderio.
Ed è qualcosa di diverso dall’istinto meccanico a fare qualcosa che fanno tutti per essere accettati e inclusi in quel particolare modo di vivere. Che non è l’unico.
Ecco allora che con ironica sapienza la protagonista ci racconta di aver scoperto di tornare ad avvertire una mancanza, un senso di vuoto, che inaspettatamente la rende incline a prestare attenzione anche alle piccole cose. Incluse quelle che nel modo di vivere precedente andavano a finire nel cassonetto, solo perché così aveva senso per il sistema economico: continuare incessantemente a produrre per poi indurre il consumatore a continuare a comprare ancora cose, perché sempre “più nuove”.
Uno spettacolo che sa far uso dei toni più scoppiettanti e provocatori per veicolare l’urgenza di riscoprire nuovi modi di vivere, diversi rispetto a quello in cui si siamo impantanati.
Assaporando la fertile tensione delle spinte di cui si compone la nostra possibilità di essere liberi: la spinta a lasciarci guidare e l’ebrezza a dare noi una direzione al nostro sentire. Perchè assecondarne solo una, rischia di essere troppo limitante, fino a diventare distruttiva.

Dafne Rubini (regista) e Martina Gatto (interprete)
Recensione di Sonia Remoli