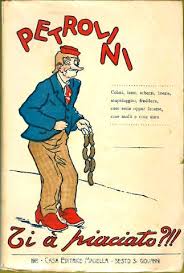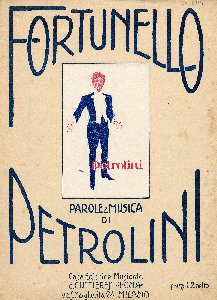TEATRO VASCELLO, Dall’1 al 6 Marzo 2022 –

Un ambiente scenograficamente scarno e insieme ricco di allusioni: una scatola in bilico? Un’isola in mezzo al mare? Un vascello alla deriva? Forse una sola di queste ipotesi, forse tutte, forse nessuna.

Siamo nel teatro dell’assurdo e in questo contesto, dal quale vengono banditi i principi base della razionalità (e cioè il principio di identità e di non contraddizione e quello di causa-effetto) l’elemento “sedia” diventa un modulo e quindi la misura di tutte le cose. Una sedia non è più solo una sedia ma anche molto altro: è il supporto sul quale si possono far sedere persone (reali o immaginarie) ma anche oggetti (un servizio da thè, degli abiti). E ancora, una scala, ma anche l’unità costitutiva di una piramide-tomba del vecchio (che resta innominato) e della vecchia, alla quale qui si attribuisce il nome-destino di Semiramide. Regina famosa, nel passato, per le fiamme della sua passionalità ma che, ora, qui, sente “un gran freddo”.

Oltre che una piramide, questa struttura triangolare di sedie può essere anche la vela di una zattera o di un vascello, disperso, che anela di andare a vedere altre vele, “splendide macchie di colore”. E per riuscire a vederle, osa sporgersi oltre il grigiore fangoso che lo avviluppa. “È colpa della Terra se tutto cambia, se più si va, più si sprofonda”. Quasi un’eco dell’adagio dell’Otello di Shakespeare: “E’ colpa della Luna: si avvicina troppo alla Terra e gli uomini impazziscono”.

Il fatto è che “si crepa di noia” – ci confessa Semiramide – e per sopravvivere non resta che giocare al “facciamo finta che”. Stratagemma per “cucinare” e quindi nutrire con qualcosa di nuovo il suo compagno, così passivamente inquieto. Lei, Semiramide, invece ha la fortuna di non ricordare quasi nulla e questo la rende “fresca” alla ripetizione: “io ho uno spirito nuovo tutte le sere”.

E grazie a questo “rinnovamento continuo” riesce a commuoversi, fino alle lacrime, durante e dopo l’ennesimo rapporto sessuale con il suo uomo. Nella liturgia della loro giornata c’è anche la cerimonia del thè, accompagnata dal vago pungolamento di lei: “tu sei molto intelligente, avresti potuto fare qualsiasi cosa, se avessi seguito la tua vocazione”.

Lui invece ritiene di aver fatto bene a non essere stato ambizioso: l’unica cosa che desidera ora è continuare a dipendere dalla sua mamma. Almeno lei lo guarderebbe, lo ascolterebbe. “Siamo tutti orfani”, conclude. “Ma ora basta ” – lo ridesta Semiramide: a breve arriveranno “gli ospiti”.

Ma chi è “l’ospite” se non lo straniero (a volte anche il nemico) al quale, per sacro e tacito accordo, tributiamo accoglienza? Un’ostilità che si sublima nell’ospitalità: atavico scambio reciproco ma soprattutto supremo e inviolabile valore di civiltà.

E soprattutto chi sono, qui, “gli ospiti”? Forse siamo noi del pubblico. Siamo noi quelle vele, “splendide macchie di colore”, che il compagno di viaggio di Semiramide (un poetico e visionario Michele Di Mauro) tanto desidera incontrare. Forse ognuno di noi può essere “l’oratore”, capace di trovare le parole per dirlo, “il proclama”: così da non sentirci “orfani”, bambini che nessuno guarda, né ascolta.

Se solo osassimo, se solo prestassimo orecchio, se solo trovassimo l’audacia: un modo di stare al mondo meno serioso del coraggio ma più temerario, e perciò più brillante. L’audace non è inconsapevole del rischio ma generosamente lo accetta e se ne compiace. E la sorte l’aiuta, perché l’audace è consapevole di sé e quindi aperto all’accoglienza, all’ospitalità.

Uno spettacolo potente che, andando al di là della miseria della condizione umana, ci ricorda qual è la nostra missione qui sulla Terra: quella di “ospiti” e di “ospitanti”.
Particolarmente degna di nota, la fulgida interpretazione di Federica Fracassi.

————————–
Maggiori informazioni sul regista Valerio Binasco
Recensione di Sonia Remoli