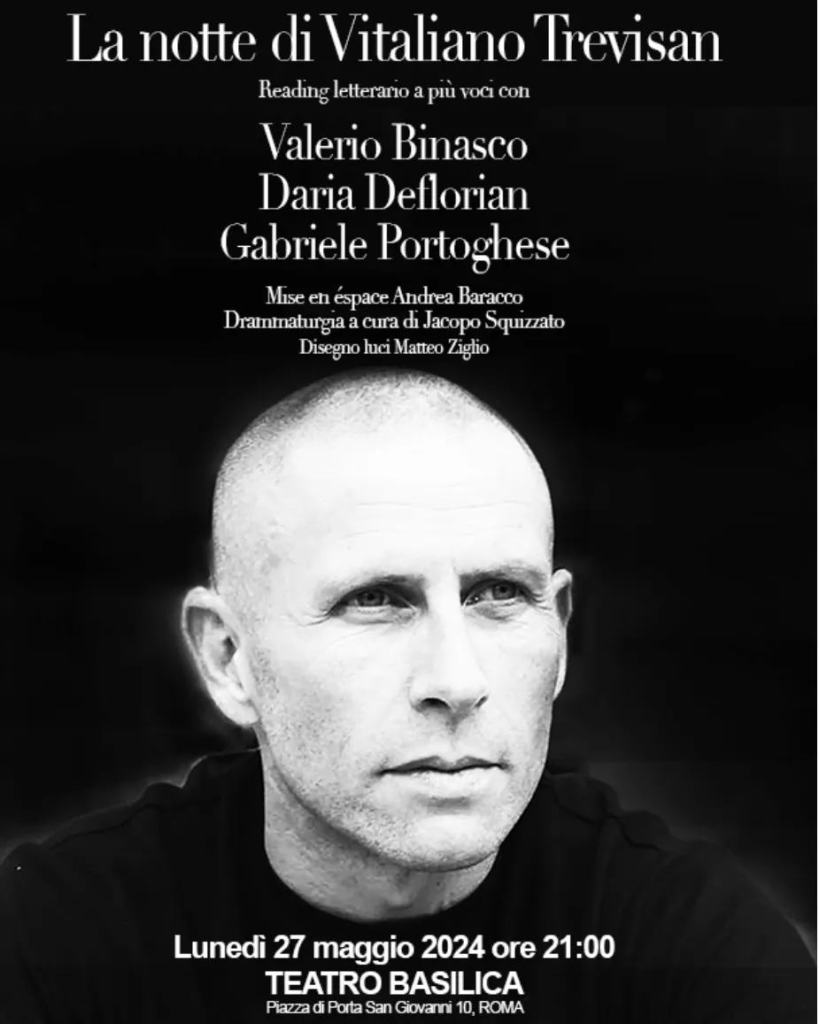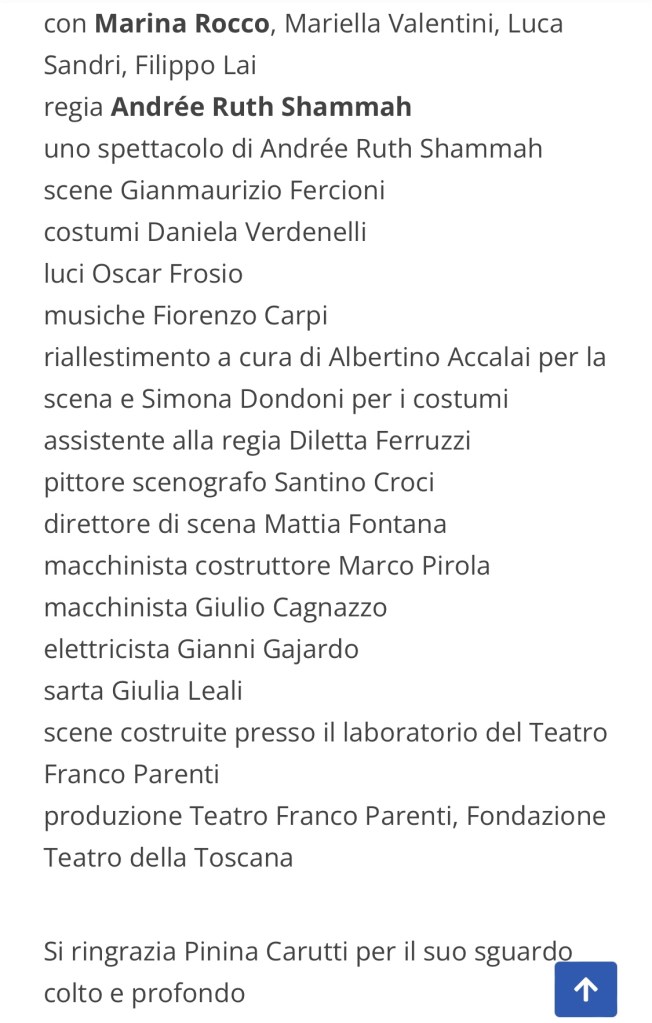TEATRO LE MASCHERE, dal 18 al 20 Giugno 2024 –

Tutto è “a vista”.
La scena riproduce un laboratorio di pasticceria, dove lavorano “dal vivo” due fratelli. Sono fratelli gemelli.
Ma qualcosa inizia a sottrarsi “alla vista”: uno dei due non ha nome proprio, prima caratterizzazione di un’identità. Il sottotitolo dello spettacolo recita: “Io e mio fratello Roberto”. E quella che sembrerebbe una privazione, inizia pian piano ad avere il sapore di una iper protezione, con un retrogusto di sopraffazione.
Acuta scelta drammaturgica di anticipare quella che è l’ontologia dei fratelli gemelli: generalmente difficili da distinguere e quindi con un’innata fame d’identità da soddisfare. Quella necessità di sviluppare un “me” separato da un “noi” diventa allora cruciale, alimentata anche dal dover competere fin dall’inizio per risorse condivise nello stesso tempo.

Leonardo Capuano e Roberto Abbiati
E così l’empatia che i gemelli provano l’uno per l’altro può trasformarsi in una lotta interiore per arrivare ad essere individui “unici”. Un mondo sotterraneo, non “a vista”, di emozioni e relativi atteggiamenti di cui, ad esempio, ci parla la balbuzie di Roberto.
Ma siamo in una cucina, il luogo per eccellenza delle trasformazioni, dove non solo i cibi ma anche le emozioni meno commestibili possono diventare pietanze gustose: utili alla vita. Serve l’azione del fuoco, non solo quello del gas ma anche quello dell’anima: quello che si sprigiona dal lasciarsi condurre dalla musica, dall’amore. Dall’improvvisare quando non si ricordano più le parole.
La scena è una stanza – un luogo fisico ma anche della mente – dove si può dar libero corso sia alla propria aggressività (grazie all’uso dei coltelli) che al propria energia sessuale. Un’energia vibrante che ripetutamente però resta bloccata da qualcosa: come l’orologio al centro della parete. Fermo all’orario in cui è avvenuto un terribile imprevisto, per sostenere il peso del quale non sono risultate sufficienti le risorse a disposizione dei due fratelli. Un trauma.

Roberto Abbiati e Leonardo Capuano
Ma non tutto nella vita può seguire delle istruzioni, come avviene per le ricette dei dolci. E tra queste cose c’è anche l’amore, che non vuole essere controllato. Ma controllare.
Sarà per questo che in amore vince chi “viene dopo”: Roberto, il fratello balbuziente che del lavoro in pasticceria fa fatica a seguire le regole della logica, finendo per dipendere dalla gestione dell’altro fratello, quello “affidabile”.
Ma Roberto è dotato di una diversa intelligenza, che va al di là dei precisi confini fissati dai principi della logica: è un‘intelligenza emotiva la sua, che gli permette di muoversi meglio negli imprevisti poetico-erotici dell’amore, ad esempio. Lui sa stupirsi (per questo può sembrare uno che “viene dopo”) e di conseguenza sa produrre stupore. E il suo sguardo, anche quando è fisso, è creativamente perso.

Roberto Abbiati
Roberto Abbiati, l’interprete, è i suoi occhi. Parlare con la voce è secondario per uno come lui: non se ne sente la mancanza. E la sua balbuzie, pur essendo un “blocco emotivo”, in realtà viene come trasformata in una preziosa gemma che caratterizza la sua individualità. Ben oltre i suoi baffi. Quando poi parla, gli esce una vocina piccola piccola ma così suadente, da veicolare meravigliosamente un’abilità (inconsapevole) nell’arte dell’uso della parola. Tanto da sedurre, in primis, il suo stesso fratello.
Ma lui, così rigido nella sua individualità, nella sua egoità, non si permette di goderne; anzi rimprovera Renato di un “cattivo” uso delle parole, che lo riducono “a un burro”. Se invece sapesse quanto è irresistibilmente amabile quando si lascia spalmare dalle parole di Roberto! Ma lui ha ancora bisogno di credere che un vero uomo deve essere efficiente e ricco in nerbo: “Io sono io e lui è mio fratello Roberto, che arriva sempre dopo”.

Leonardo Capuano e Roberto Abbiati
In verità il meno identificato dei due fratelli è proprio lui: ancora così traumaticamente legato a suo padre e ai propri rigidi confini personali. E Leonardo Capuano, che lo interpreta, sa rendere con sensibile efficacia questo suo intimo dissidio, colto così bene da Roberto:“ Mio fratello non è nato simpatico, parla bello sciolto e mi legge nei pensieri”. E’ un uomo pervaso da una forte carica erotica che agisce nella manualità che necessariamente si sprigiona in una cucina, metafora della donna ideale: la mamma. Ma la sua manualità non riesce a decollare fuori dai luoghi comuni delle ricette seduttive. Si fida solo di se stesso e delle sue bavaresi alla fragola e non ce la fa ad incuriosirsi fino a farsi preda del mistero che incarna una donna. Lui sa essere protettivo con le sue donne (le bignoline) e con suo fratello: ma la protezione è una forma di controllo non di arrendevolezza, di scioglievolezza.

Roberto Abbiati e Leonardo Capuano
Per questo è così spaventato dall’effetto che gli suscitano le parole di Roberto: lo fanno sentire perso, disorientato. Gli fanno perdere la memoria: e si blocca. E così lo spettacolo. Come l’orologio, che ricorda ossessivamente, ma silenziosamente, qualcosa di incontrollabile. Di cui non riescono a parlare tra loro i due fratelli. Ma con noi del pubblico sì, in teneri a parte. Questa esperienza familiare traumatica, come a suo modo può esserlo l’amore per una donna, richiede però di essere ancora ben “amalgamata” – dolcemente sì, come ordina il fratello a Roberto – ma anche rendendosi disponibili a una trasformazione.
Di cui si hanno i primi segnali nella modalità di preparazione dell’ultimo dolce della serata: una torta Charlotte, alla quale i due fratelli gemelli lavorano finalmente a quattro mani, senza subordinazioni. Un “noi”, dove trova libera espressione lo stile e quindi l’identità di ciascuno dei due pasticceri.

Leonardo Capuano e Roberto Abbiati
Uno spettacolo gustoso, profumato, eccitante, commovente, sorprendente: ingredienti follemente amalgamati all’interno di una drammaturgia calvinianamente leggera, portata ogni volta alla giusta temperatura da due interpreti irresistibili.

Leonardo Capuano e Roberto Abbiati
Recensione di Sonia Remoli