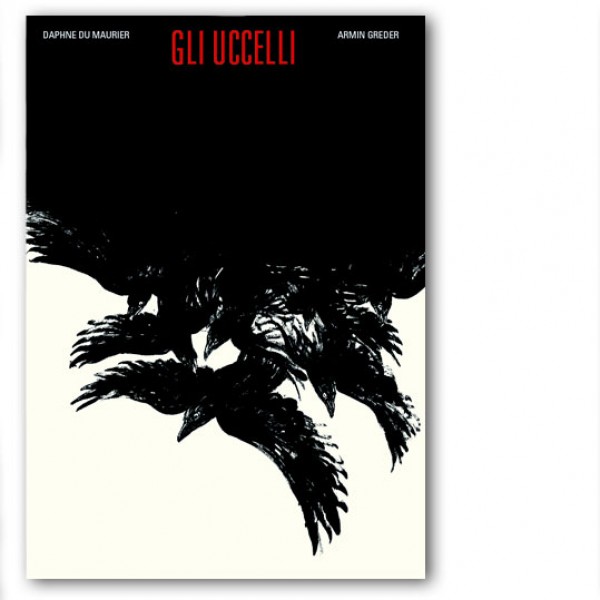TEATROSOPHIA, dal 12 al 14 Maggio 2023 –

Lo sguardo cinematografico che permea la regia e impreziosisce la graffiante drammaturgia di Massimiliano Auci dà vita ad “un monologo a tre voci”, ricco in assolvenze e dissolvenze, echi e specularità.

Massimiliano Auci, autore e regista dello spettacolo “Medea, la divina”
In un efficace gioco di flash-back, il vissuto della “persona” Maria Callas finisce per fare da contrappunto a quello del personaggio “Medea” di Pier Paolo Pasolini.

Maria Callas
Entrambi rimandano, infatti, a una predisposizione delle due donne verso amori folgoranti per uomini carismatici ma poco disponibili a riconoscere il loro autentico valore, unitamente ad un particolare rapporto sventurato con i propri figli. Donne ostinatamente ambiziose e di successo ma penalizzate da un insano rapporto con il cambiamento.

Maria Callas in “Medea” di Pier Paolo Pasolini
È il vento ad aprire infatti lo spettacolo: un movimento vitale che allude all’energia che muove il corpo fisico, ma anche lo spirito, in un cambiamento continuo da uno stato all’altro. Perché così è la vita, dove tutto si muove tra continui equilibri e sconvolgimenti. Il piacere, il fastidio e la paura provocate dal vento porteranno l’attenzione sugli aspetti della vita delle due donne che sono ormai “maturi” per una trasformazione e quelli invece che seguono vie meno controllabili. Alle quali ci si dovrà adeguare, malgrado tutto.

Maria Callas
Evocativi e poeticamente onirici i corridoi di luce, sviluppati su diversi campi cinematografici, dove una giovanissima Ginevra Gemma, piena di grazia, osa farsi guidare dal lancio di un sassolino per saltare sulla vita.
Dagli scacchi del gioco della campana, tra assolvenza e dissolvenza, il passaggio è sulla cappa a scacchiera che veste la Medea-Callas, interpretata da un’appassionata Giovanna Cappuccio che, con fiera e fragile tragicità ha deciso di lasciare in eredità ai figli, privi di una madre, una città. Ma si spoglierà di questo proposito così come ora fa con la cappa che l’avvolge, quasi a rifiutare gli scacchi ricamati per lei dal destino.

Giovanna Cappuccio
In un interessante gioco a cerchi concentrici, il nuovo “habitus” della Callas-Medea, total black, ricorda quello sulla “de-formità” del Riccardo III shakespeariano: “io che non sono nata per i lavori nei campi…”. E’ una mancanza di quella “giusta forma” necessaria per essere riconosciute dagli altri ma soprattutto da loro stesse.

Giovanna Cappuccio
E così, Maria si lascia plasmare, “sempre indifesa”, dall’imprenditore Giovanni Battista Meneghini che la trasformerà da goffa donna a rilucente diva. Ma se ” arrivare è da molti, restare è per pochi! “. E così Maria (ma anche Medea) finisce per infilarsi in un illusorio mantenimento della continua perfezione che sfocerà in una vera e propria maniacalità.

Giovanni Battista Meneghini e Maria Callas
A una seducentemente subdola Giorgia Serrao sono affidati i contrappunti della madre e delle sfaccettature nascoste della diva indifesa e arrabbiata.

Giorgia Serrao
Finché non arrivano altri due nuovi occhi a voler plasmare la divina: quelli di un altro imprenditore: Aristotele Onassis. Una di quelle persone che pretendendo di essere amate, non sanno amare.

Aristotele Onassis e Maria Callas
Abbandonata, le serve una nuova identità: questa volta il nuovo “habitus” arriva da Pier Paolo Pasolini. Su di lei “cuce” il suo personaggio di Medea. Entrambi reduci dalla fine di un grande amore, si amano. Ma di amori diversi. Il vento continua a soffiare cambiamenti ma per Medea la divina saranno solo fratture.

Pier Paolo Pasolini e Maria Callas
Uno splendido ritratto al di là di della leggenda e al di là del divismo che, sempre con il giusto ritmo, porta lo spettatore a scoprire due nuove donne allo specchio. Nelle quali non è difficile trovare assonanze con i nostri vissuti.

Giovanna Cappuccio e Giorgia Serrao