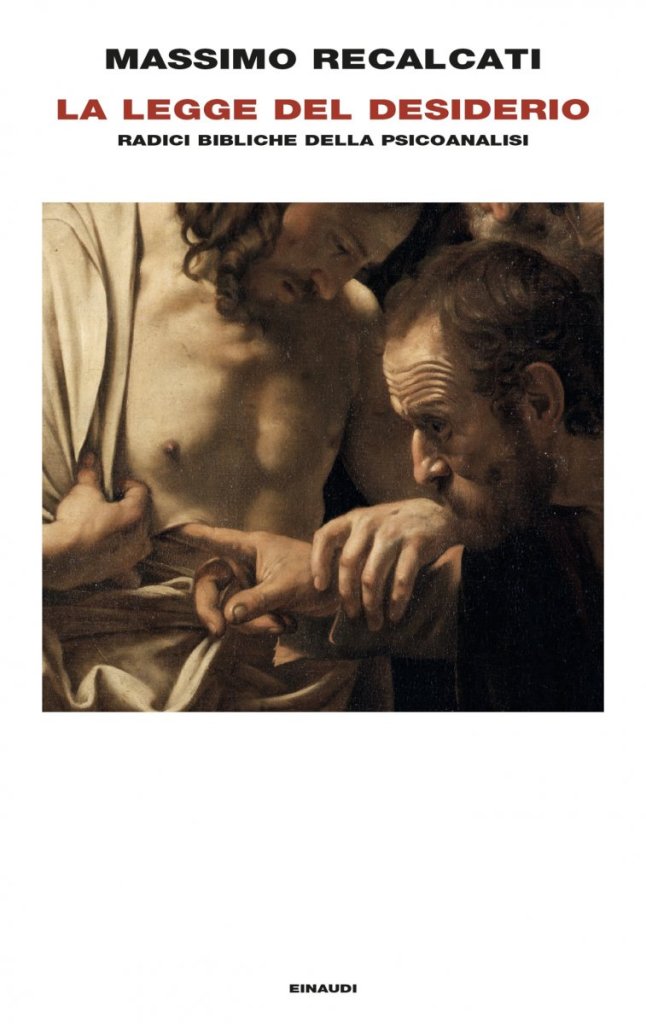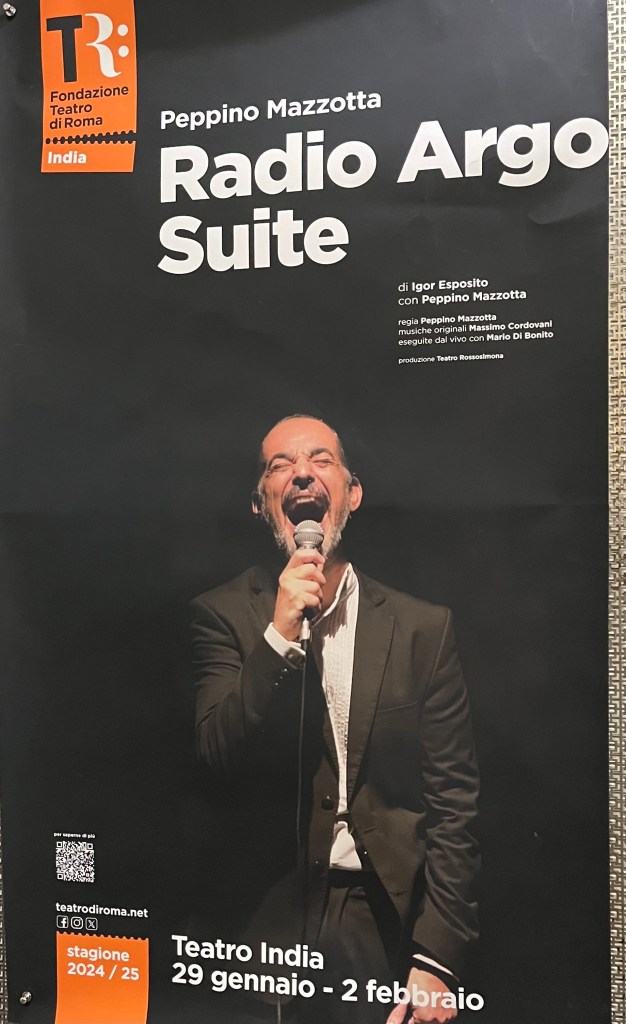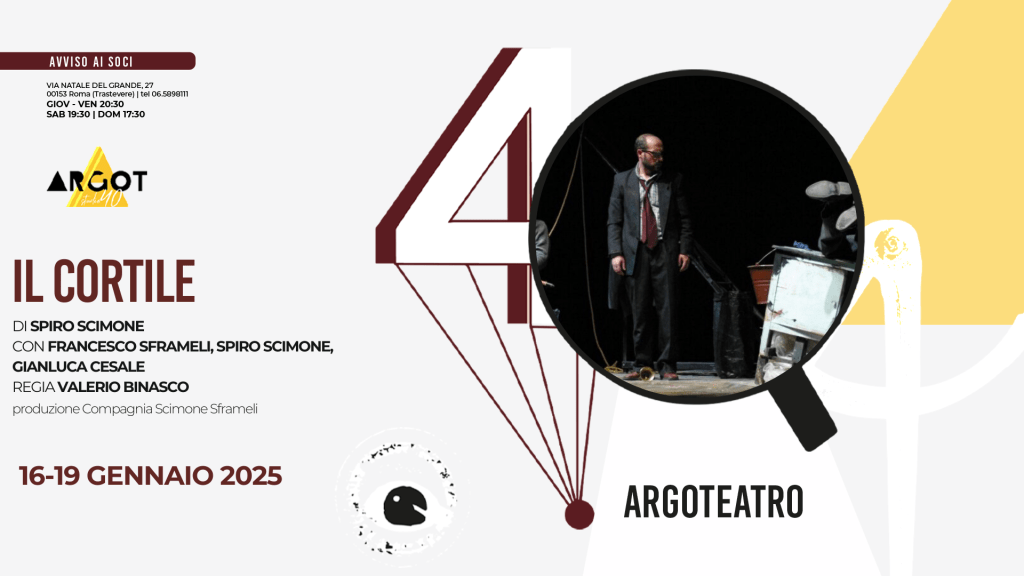TEATRO INDIA , dal 5 al 9 Febbraio 2025

Guardare, essere guardati: sono esperienze che viviamo continuamente, più volte al giorno, tutti i giorni. Tanto da essere diventati quasi degli automatismi.
Ma poi arriva questo percorso scenico di Liv Ferracchiati: qualcosa di innocuo e di sconvolgente.
E ti ritrovi in un incantesimo.
Qualcuno guarda un oggetto desiderabile. Anche noi del pubblico. E’ bello, sì; invitante, anche. Gustoso. Ma niente di sconvolgente. Se però la seduzione sposta il suo mezzo dall’occhio all’orecchio, e quindi sul suono della parola dell’oggetto desiderabile, sul ritmo e sui sottotesti con i quali questo nome può essere evocato, qualcosa cambia. Ma ciò che davvero è solleticante, e quasi urticante, è il suo suono onomatopeico. La vibrazione ruvida e delicata di un fruscio: “frrrr”. Come qualcosa di scabrosamente bello. Ma quel qualcuno che guarda, dice di poterne rimanere immune.
Poi la situazione muta: quel qualcuno guarda noi, ci inquadra con una macchina fotografica. Ci esplora con il suo sguardo. Dice che vorrebbe navigare tra di noi come fossimo canali. E poi incontra qualcosa di desiderabile. “Tu, sì tu, tu sei di una bionditudine assoluta” – pensa guardandolo. Ci rivela però che, conoscendosi, sa che può dominare anche questo desiderio. Ma l’altro, il biondo, si alza dalla platea per raggiungerlo. Ed entra in dialogo con il suo sguardo. Ora, non c’è dominio: solo silenzio, meraviglia e sgomento. Come di fronte a qualcosa di inesplorato.
“Nulla esiste di più singolare, di più scabroso, che il rapporto fra persone che si conoscano solo attraverso lo sguardo” (Thomas Mann, La morte a Venezia)
Venezia: la bellezza della sua acquaticità. Quella che si lascia guardare, che si volta, che si fa onda (è la danza di Alice Raffaelli). Una sinuosità inafferrabile. Ma penetrante. Come oggetto desiderabile, come Tadeus. E’ di un colore indefinibile il desiderio che evoca, è espressione di particolari. Scuote chi la guarda.
Non bisognerebbe guardarla: sgomenta di bellezza. Ma Gustav si scopre a non riuscirci: “oscilla”. Si lascia dondolare da un soffio: un movimento proprio del dio e non dell’uomo. Gustav oscilla perché mosso dal vento del divino.
Tadeus sembra parlargli. Ma Gustav si rammarica di non “decifrare” le sue parole. Non è necessario, non serve capirsi con le parole. Basta incontrarsi sull’orlo dell’elemento acquatico. Qui, sull’orlo, fa un caldo opprimente, afoso. Forse è la seduzione dell’inarticolato. Dell’informe. Dell’inesplorato. Dell’aperto. Dell’indecente. Del suono delle onde che lambiscono il lido.
Gustav si sente posseduto dall’urgenza di “scrivere” in sua presenza: al cospetto di Eros. Ora “sente”. Lì, sull’orlo. Ma è scabroso. Cerca certezze nel suo sguardo, nella scrittura. E’ dilaniante. Gustav scopre che il mondo è indicibile. Perché lui è incontentabile.
L’incontro e il mancato incontro con inesplorato inizia a produrre segni sul corpo di Gustav. Qualcosa inizia a deformarsi, ad invecchiare.
E poi è così stanco.
“Se tu potessi truccarmi per rendermi meno goffo e più bello ! – chiede Gustav a Tadeus – ora so che conosco male i miei desideri”.
“Ora so cosa significa essere nudo”.
Qui accade qualcosa: a questo punto del percorso scenico, a questo punto del dialogo fra sguardi, quando Gustav inizia a parlare con quel suo sentire nudo, con quel suo volto nudo – che si fa insieme supplica, grido, preghiera – si può fare esperienza di stare con lui sull’orlo del mondo.
E può prendere forma una lacrima, incapace di trattenere oltre, tanta lacerante bellezza.
Una scrittura incalzante e seducente: piena di meraviglia. Capace di indagare e restituire l’oscillante turbamento del punto d’incontro tra il ruvido e il delicato: lo scabroso.
Una regia piena di specchi, labirintica. Eppure ferocemente limpida.
Recensione di Sonia Remoli