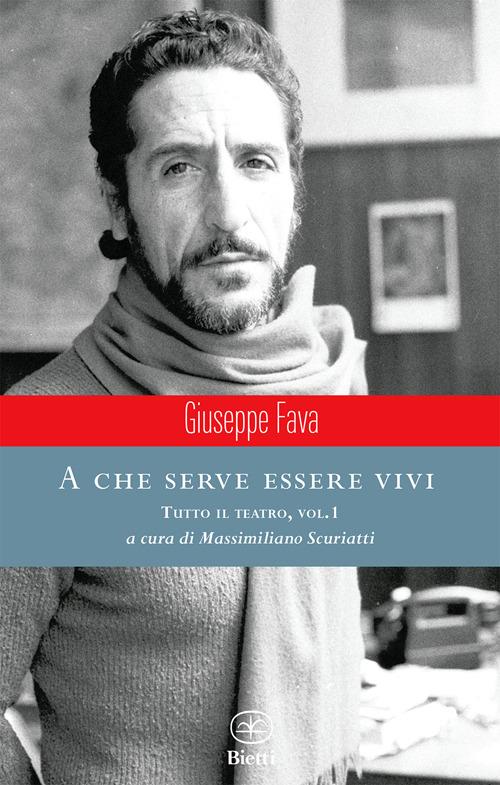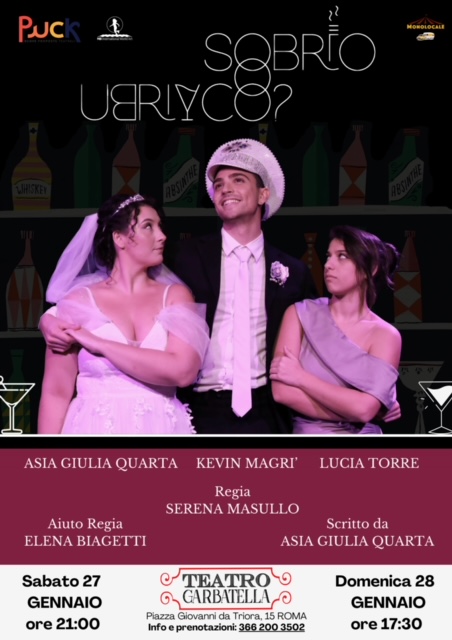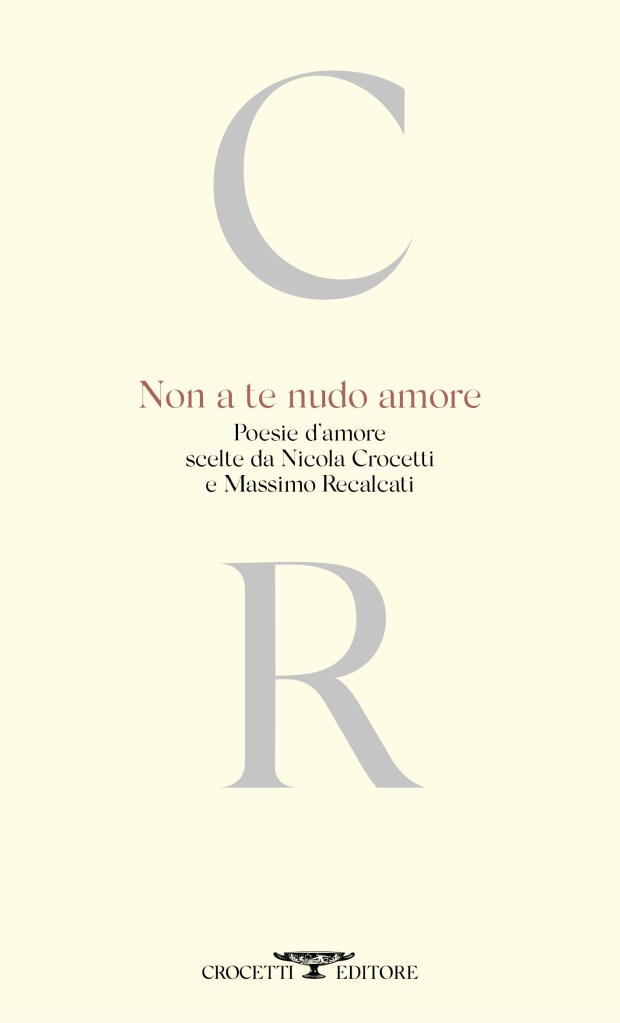
In quanti modi si può sperimentare l’amore?
In quanti modi si riesce a parlarne, introducendosi nel mistero dei misteri ?
Sotto quante coltri siamo disposti a scendere e a perderci, fino a scoprirci inermi di fronte all’Eros ?
Tra le varie lingue, è quella poetica a riuscire ad avvicinarsi più temerariamente all’arroventamento amoroso. E così – proprio perché più disponibile a lasciarsene contagiare fino a perdere il governo di se stessa – può restituirci l’incandescenza di quel rosso ardere, che arriva a virare nel bianco della massima luminosità.
Lo sosteneva Novalis e ne riconosce la maggiore efficacia rispetto alla lingua della scienza e a quella della stessa psicoanalisi Massimo Recalcati, psicoanalista tra i più noti in Italia.
Ecco allora che dal desiderio di esplorare le caleidoscopiche forme dell’amore nasce la raccolta di poesie “Non a te nudo amore, che riunisce le testimonianze lasciateci dai poeti a noi più lontani nel tempo, fino ad arrivare a quelle dei poeti che con noi stanno condividendo il presente.
Selezionate dalla sinergica fine sensibilità di Nicola Crocetti, traduttore e riconosciuto “editore dei poeti”, e di Massimo Recalcati, celebre psicoanalista e saggista, queste poesie invitano – come solo la più nobile accoglienza sa fare – a mettersi in gioco. Ad aprirsi cioè verso uno sperimentare in purezza, superando quel senso di disorientamento suggerito dal titolo.
Perché “Non a te nudo amore”, primo verso della lirica “Io attesto” di Andrea Zanzotto, ci parla di uno sbandamento emotivo che prende la forma di uno scavalcamento. Di una mancata considerazione. Ma è proprio questo incipit negativo a sortire l’effetto di incentrare l’attenzione su ciò che viene sottratto.
Perché “quello della poesia – al pari di quello dell’amore – è un mondo di sbagli, di allucinazioni, di torpori, di rigiri a vuoto, in cui s’incontra di tutto …”.
E’ un mondo che coinvolge e che sconvolge: un mistero a cui si accede per negazione, per sottrazione di sponde:
“Bisogna amarsi meno,
bisogna lasciare al tempo
l’ingorda gioia d’insegnare
che l’amore non è ricevere,
né dare,
ma lasciarsi prendere,
affondare”.
( Giovanni Testori )
E’ un darsi come “esca amorosa”, ci confida il Petrarca.
È un “non penso a te, ma sono per amore tuo” di Rilke.
È qualcosa “che ci sviva, vi sviva tutti. Di più”, insiste la Gualtieri.
E forse non è un caso che questa condizione venga spesso associata ad un particolare elemento atmosferico: il vento. Che solletica, spazza, travolge, delocalizza.
Ma solo questa vaghezza, solo questo mollare è la condizione che permette di accedere al “rito del due”. Quel rito che ha il potere di dare vita a un nuovo spazio, a un nuovo mondo: quello della Relazione.
“Senza di te un albero
non sarebbe più un albero.
Nulla senza di te
sarebbe quello che è”.
( Giorgio Caproni )
Uno spazio dove l’individualità si scopre incline a cedere il passo ad un misterioso voler creare e condividere insieme un nuovo sguardo sul mondo. Uno sguardo unico: quello di me e di te. Uno sguardo che “sfiora” l’epidermide dell’eterno. E ne trema: “amo in te l’impossibile ma non la disperazione” (Nazim Hikmet).
Per questo se poi un amore finisce assume la potenza di un trauma: perché non viene meno solo un legame emotivo, ma un’ontologia. Viene meno cioè quel mondo che poteva continuare ad esistere solo “insieme”, in due: quello fondato da me e da te.
“Riunito è tutto ciò che vedemmo,
a prender congedo da te e da me:
il mare, che scagliò notti alla nostra spiaggia,
la sabbia, che con noi l’attraversò di volo,
l’erica rugginosa lassù,
tra cui ci accadde il mondo”.
( Paul Celan )
Ma l’amore può anche non concludersi: può rinnovarsi. Può durare.
Quando ad esempio diventa preziosa consapevolezza di una quotidiana “intesa”, dice Peter Handke, che “il racconto” ha il potere di propagare in onde. Ma richiede “esercizio”, anno dopo anno: solo così può arrivare
[…] “del tutto inatteso
il brivido della durata
e ogni volta per gesti di poco conto
nel chiudere con cautela la porta,
nello sbucciare con cura una mela,
nel varcare con attenzione la soglia,
nel chinarmi a raccogliere un filo”.
( Peter Handke )
Il mistero dell’amore si manifesta attraverso una nitida sensazione: che l’anima necessita di un corpo per essere rintracciata. Per produrre epifanie: un po’ quello che Hölderlin definiva il raggiungimento del “libero uso del proprio”:
“La prima volta non fu quando ci spogliammo
ma qualche giorno prima,
mentre parlavi sotto un albero.
Sentivo zone lontane del mio corpo
che tornavano a casa”.
( Franco Arminio )
—
Toccami,
il corpo solo in apparenza tace,
se passi una mano sulla pelle
torna l’arancio della brace.
( Viola Vocich )
—
Ma che cosa siamo davvero noi per l’altro ? Siamo davvero ciò che noi pensiamo di essere per lui/ lei? Pungente è la sensazione di saperlo. Urgente l’esigenza di verificare, di indagare. Ma qualcosa sfugge. Sempre.
[…] ciò che tu vedi non è
ciò che io vedo e ciò che prendo
non è ciò che tu dai […]
( Göran Tunström )
Ma forse è meglio così; meglio non soddisfare troppo la fame di certezze.
Solo così si arriva ad arrendersi al voler capire, disponibili a consegnarsi nudi al mistero dell’amore: ad occhi chiusi.

Recensione di Sonia Remoli