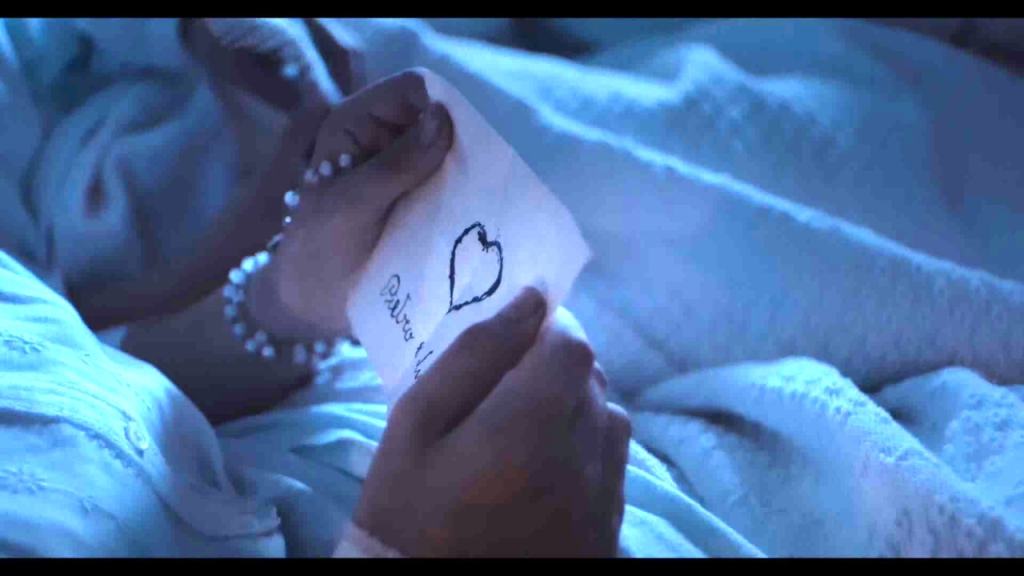LA PELANDA, Ex Mattatoio di Testaccio – 8 e 9 Ottobre 2024

L’8 e il 9 Ottobre u.s. anche Roma è stata contagiata da spore di creatività che si sono liberate nell’aria: l’epicentro si è verificato in prossimità degli spazi della Pelanda, presso l’Ex Matttatoio di Testaccio ma poi il raggio di diffusione è stato tale da non essere quantificabile. Certo invece è che, per loro natura, le spore di creatività sono capaci di sopravvivere alle più avverse condizioni ambientali. E riprodursi.
Il Romaeuropa Festival ha ospitato infatti l’ultima tappa di Spores Project: trasformazioni artistiche tra poesia, scienza e nuove tecnologie.

Progetto vincitore di “Europa Creativa 2022” focalizzato sull’intersezione tra sperimentazione intermediale, arti performative, sostenibilità e innovazione audiovisiva.
Uno spettacolo itinerante composto da un collettivo di artisti di grande spessore come Federica Altieri, Flavia Mastrella, Antonio Rezza, Maria Letizia Gorga, ACRE+Michael Thieke, Eugenio Barba, Julia Varley, Valerio Magrelli, Paola Favoino, Ashai Lombardo Arop, Giovanna Zanchetta, Claudio Ammendola, Valerio Peroni e Alice Occhiali, i quali hanno performato insieme a giovani promesse come: Giuliano Logos, Gabriele Ratano, Riccardo Gadenzi, Cora Gasparotti, LOTTA, Sharxx, Gioia Perpetua, Sacha Piersanti, Daniele Torracca Oriana Cardaci, Valentina Pacifici, Carlo Ronzon i, Yurii Khadzhymiti, insieme ai ragazzi dei corsi di formazione “Spores” e insieme agli allievi della Palestra delle Emozioni (313).
A tutti gli artisti appartenenti ai diversi ambiti dell’arte performativa è stata chiesta una rielaborazione del concetto di Creatività.

La Pelanda dell’ex Mattatoio di Testaccio
Ecco allora che in questa due giorni di fertili contagi il viaggio dello spettatore nel “Paese della Creatività” ha avuto inizio con un’immersione sonora e il suo possibile riflesso visivo. Un po’ come se il ritmo e le sonorità sprigionate venissero creativamente visualizzate – oltre che sulle pareti del locale – anche sulla tela di possibili muri osmotici, in dialogo con i muri reali. E poi ci sono i corpi degli spettatori: anche loro superfici carnali coinvolte nel gioco del riverbero e della proiezione. Una splendida sinergia tra il suonare uno strumento e insieme l’essere uno strumento che si lascia suonare. Tra il possedere e l’essere posseduti. Tema comune – e diversamente declinato – di tutte gli incontri di contagio creativo della serata.
Lungo le vie di questo caleidoscopico Paese può capitare di incontrare chi in intimo dialogo con la luna intonasse un melanconico canto, seduto sul davanzale della propria finestra di casa e chi invece scegliesse di riportare in casa una protesta che prima aveva fatto girare lungo le vie del paese.
Si respira ovunque la bellezza di restare sospesi, di non avere necessariamente i piedi per terra: ed è inebriante tanto quanto angosciante. Perché la libertà creativa può spaventare, anche.
E’ il paese dell’interrogarsi: ovunque ci si chiede – tra il sedurre e l’essere sedotti; tra il sopraffare e l’essere sopraffatti – cosa valga la pena proteggere. O cosa fare del dono della parola, in un orizzonte “senza un cristo da inchiodare per dispetto”.
Soffiano per le vie venti di tragiche profezie; soffia ovunque la Poesia qui nel paese della creatività dove tutto trova accoglienza. Anche la violenza, in tutte le sue forme energetiche. Perché forte è la tentazione a brillare fino ad esplodere: a sapersi fino in fondo. Qualcosa che ci tenta irresistibilmente ma che poi, se raggiunto, non riusciamo a tollerare.
Ci siamo seduti in una delle piazze ad anfiteatro di questo Paese, rapiti e contagiati da un desiderio di volare, di spingerci più in alto possibile, e poi di vedere. Tutto.
E’ energia, è respiro, è voce: è ossigeno per le cellule della creatività.
Un desiderio di lasciarsi andare ad habitat onirici di stupefacente bellezza surreale, dove risiede la polivalenza, la polimorficità, l’ambiguità, l’incertezza.
Un desiderio di zummare lo sguardo fino ad avvicinarci così tanto, da esserne risucchiati; un desiderio di allargare l’orizzonte visivo, fino a perderci in esso. Un desiderio di tutto, dove è bandito ogni “senza”. Un desiderio di “fino in fondo”. Fino a sbagliare.
E ci si chiede: “di chi è la colpa?”.
E diventa una domanda ossessiva, che si fa eco. Un’eco che fa trapelare anche una possibile risposta: “bastava ascoltare”.
Basta pensare che non è tutto nostro.
Basta pensare che il piacere più grande è quello di condividere e non quello di possedere. E che “parlare” è anche una responsabilità.
Camminando ancora, abbiamo incontrato donne che parlavano danzando; vestite di abiti e di veli, come pareti scelte per proiettare e continuare a portare con sé il proprio passato. Per poi avanzare, crescere e spogliarsene, lasciando che la proiezione del passato diventasse consapevolezza.
Il Paese della creatività è sulla costa, bagnato dal mare. E così ci siamo fermati sulla spiaggia, attirati dall’inquietudine dell’habitat marino. E da una nave in difficoltà. Nella tempesta, luogo fisico e della mente, è tutto un chiedere e un chiedersi. L’ammiraglio diventa come l’amministratore di un condominio psichico: l’oracolo da cui tutti vanno in pellegrinaggio a chiedere cosa fare. E lui, con feroce sagacia, gestisce il panico della meraviglia del reale. Ascoltarlo ci fa sorridere, anche. Ci piace il suo piglio feroce e disincantato. L’incanto del suo disincanto. E’ una dissacrante forma di sublime creatività: quella propria di Antonio Rezza.
Lasciata la spiaggia ci avviciniamo ad una zona ricca in ritmo, sonorità, concitazione, eccitazione. Una zona di un’affascinante arcaicità, potentemente contagiosa. Come quella propria del legame viscerale di una madre con il proprio figlio, oppure quella che si libera in noi partorendo nuove rappresentazioni di noi stessi. Sonorità, ritmi, richiami che danno vita a un indomito linguaggio del corpo. E non solo. Sono corpi che sanno sprigionare luci, scritture luminose, disegni. Confini come riflessi specchianti. Ed è magia.
Voltandoci ci accorgiamo poi di un giovane che si sta prendendo cura del suo spazio vitale: lo sta liberando da scorie, rifiuti. Sono anche pensieri, i suoi, che si ripuliscono dall’egoismo, dal delirio di onnipotenza di credere di essere come un dio. Pensieri che ora, depurati, riescono a nutrirsi di vicinanza epidermica, di anse che ammorbidiscono ansie. Così l’attenzione creativa può indirizzandosi verso la ricerca di possibili soluzioni, anziché restare incastrata nell’ossessivo biasimo delle colpe, dove l’esistere entra in sterile conflitto con il vivere. Perché “la noncuranza ci uccide ma senza umanità il mondo comunque vive”.
Dietro di lui si fa spazio una giovane donna che fa coppia con il suo contrabbasso; la sua durezza sembra sposarsi con quella delle corde del suo partner musicale. Come un’amazzone indossa una faretra dove custodisce il suo archetto, quasi fosse un’arma. Ma questa non è musica: è qualcosa che si è allontanato dall’accoglienza generosa della creatività: dal suo bel caos, da cui “può nascere una stella danzante”. Ecco allora però che la giovane donna in crisi creativa ed esistenziale sa interrogarsi chiedendosi se ha ancora senso il suo voler fare musica. Se è disposta anche a essere musica e a lasciarsi suonare. Sì, perché la musica è un linguaggio di trasformazioni. Perché il mondo si può cambiare senza mostrare necessariamente l’arma della durezza ma facendosi musa di un’arte.
Con il ritorno circolare di questa splendida metafora sulla corrispondenza tra il possedere e l’essere posseduti l’esplorazione del Paese della Creatività ha raggiunto una momentanea conclusione. I saluti della coordinatrice anarchica Federica Altieri e della demiurga di habitat fantastici Flavia Mastrella sono stati un arrivederci, contaminato da quel senso di vuoto che contraddistingue ogni separazione. Vuoto che ci permette di continuare a desiderare, a voler ancora esplorare, contaminare, essere contaminati. Creativamente: come spore e da spore.

Recensione di Sonia Remoli