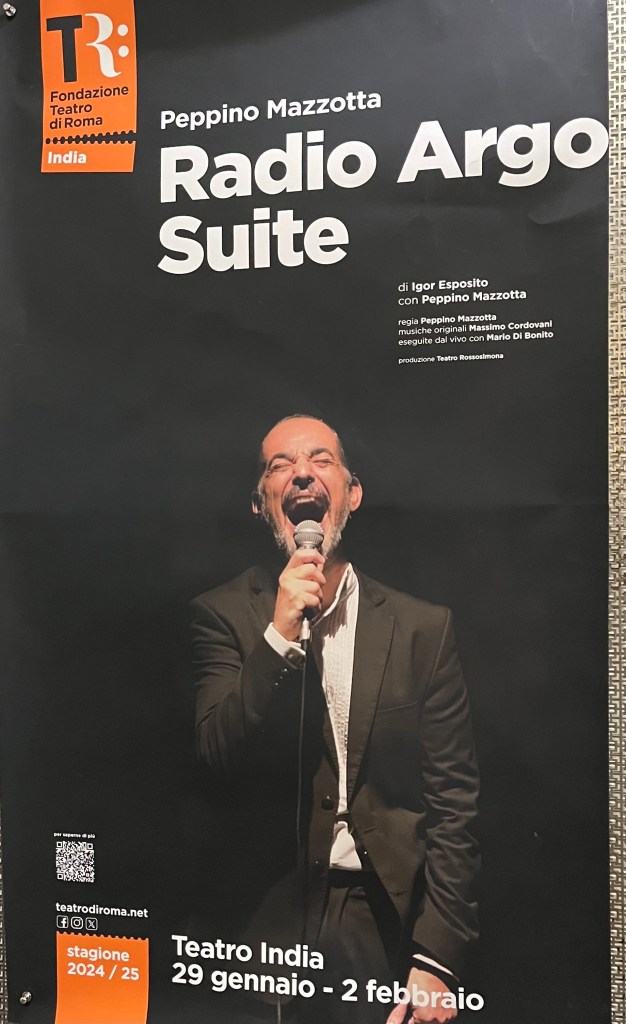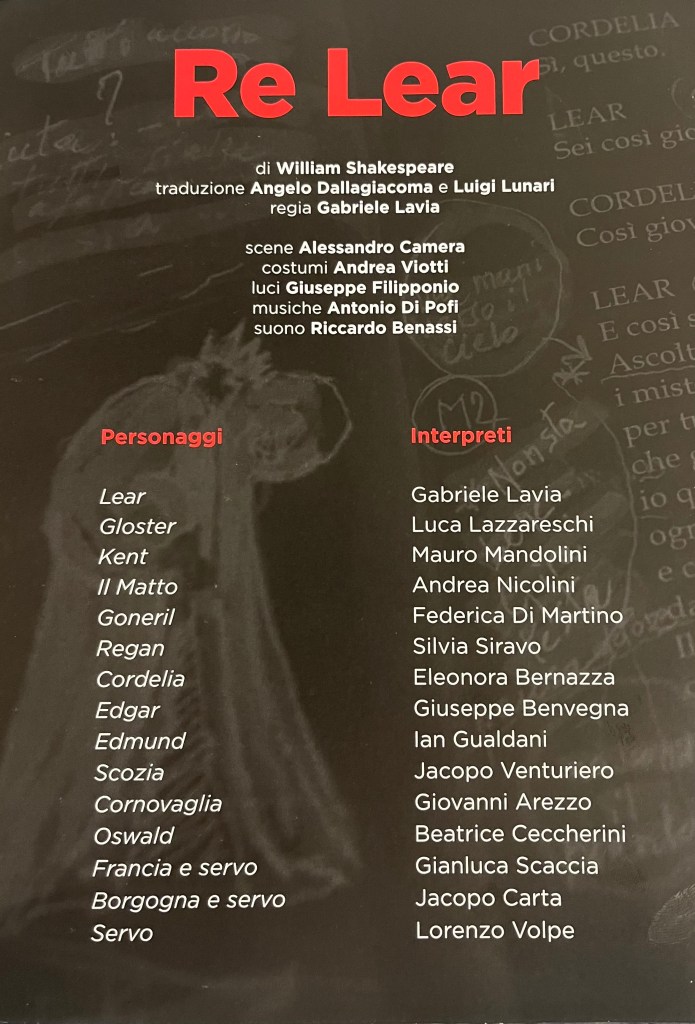dall’11 al 23 Marzo 2025

Cosa ci spaventa di più’ ?
Essere malati e non poter essere curati? – sembra chiederci questo testo dalla bellezza ombrosamente tagliente di Juan Mayorga.
C’è qualcos’altro che deve spaventarci, ci avverte Mayorga.

Juan Mayorga
Soprattutto perché tendiamo a sottovalutarlo: il pericolo terribile che si insinua in noi quando perdiamo di vista il potere delle parole.
Perché le parole non servono solo “per intendersi”, come crede Felicia, la donna che nello spettacolo farebbe di tutto (come noi, d’altronde) pur di assicurare un trattamento terapeutico a suo marito, malato.
Perché in un possibile futuro ci potrebbe “venir detto” – proprio come qui nel testo di Mayorga – che il governo si riserverà di provvedere alla cura solo di certe malattie e non di altre.

Elena Bucci (Salinas) – Monica Piseddu (Felicia)
(ph. Laura Farneti)
E allora, presi in trappola e saccheggiati da sciacalli – che invece ben conoscono il potere delle parole – potremmo credere, colti dalla disperazione, nell’efficacia di trattamenti alternativi. Pagabili non con il denaro ma con qualcosa di molto più prezioso: la disponibilità a perdere il nostro potere sulle parole. E quindi su noi stessi. Perché le nostre parole costituiscono la nostra identità.
Ritrovandoci, così, senza alcun potere. Deboli e soli. Consegnati alle loro mani, interessate a renderci ciò che desiderano fare di noi: servitori.

E saremo la nuova versione degli antichi “golem“: creature fatte di materia informe, perfette da plasmare a piacimento altrui. Informi perché senza parole proprie. E quindi senza pensieri e senza opinioni proprie, che sole ci danno una forma e quindi un’identità. E quindi un potere.
Saremo, così, creature alle quali si potranno mettere in bocca parole specifiche, il cui potere altri sceglieranno, perché capace di renderci fedeli servitori dei loro interessi.

Jacopo Gassmann
La potente bellezza della scenografia – pensata con acuta visionarietà da Jacopo Gassmann, realizzata con maestria da Gregorio Zurla, scolpita con un sapiente uso delle ombre da Gianni Staropoli, moltiplicata e allucinata dalle proiezioni di Lorenzo Letizia e immersa in un’elettrica suspence sonora da Giorgia Mascia – ce ne parla fin da subito: oscure strutture specchianti sono montate creando apparentemente un punto di fuga: una soluzione. Ma non è quello che sembra. E la possibilità di fuga si rivelerà un modo per stringere all’angolo la coppia protagonista della storia. E predarla.
Magnifica visualizzazione, la scena, di come le parole possono creare realtà che potrebbero nuocerci, sebbene chi ne conosce il potere sceglie di farle passare come parole salvifiche.

Woody Neri (Ismaele) – Monica Piseddu (Felicia) – Elena Bucci (Salinas)
(ph. Laura Farneti)
Il potere comunicativo della parola, quello cioè che attribuisce alla parola un unico significato – fissato per convenzione in base ai principi della logica – é utile per capirsi. Ma solo superficialmente. Per avvicinarsi alla verità occorre conoscere invece il potere plurivalente delle parole. Un potere magico, generativo, che se conosciuto solo dall’altro potrebbe nuocerci, in quanto la nostra ignoranza ci impedirebbe di smascherarlo. E quindi di difenderci.

Monica Piseddu (Felicia) – Woody Neri (Ismaele)
(ph. Laura Farneti)
Perché scegliendo le parole si sceglie, si genera e si dà forma ad una realtà. Per questo motivo la parola e la magia sono da sempre così legate. Un consapevole ed esperto uso della parola ha un impatto formidabile sulla vita umana: migliore è il nostro uso delle parole, migliore sarà il nostro potere sulla realtà.
Solo per fare un esempio: Robert Levy, antropologo statunitense che negli anni ‘50 condusse degli studi sull’alto tasso di suicidi che affliggeva Thaiti, scoprì che nella cultura e nella lingua thaitiana non esisteva la concezione del dolore, fuorché quello fisico. Davanti al dolore interiore allora, per il quale non avevano parole per esprimerlo, i thaitiani si suicidavano.

Monica Piseddu (Felicia) – Woody Neri (Ismaele)
(ph. Laura Farneti)
Qui nello spettacolo di Jacopo Gassman, Felicia viene avvicinata da Salinas, una donna misteriosa, che fa parte di una strana organizzazione sanitaria. Da giorni sta studiando il modo di predarla spiando i suoi modi di fare, perché i suoi modi sono il risultato delle parole che lei sceglie per definirsi. Da essi, dai suoi gesti, dalle sue scelte – solo apparentemente banalissime come ad esempio quella di scegliere di bere della birra analcolica in un bicchiere di plastica – può risalire alla maniera in cui far presa su di lei, convincendola subdolamente a collaborare.
Sapientemente, e generosamente, la regia di Jacopo Gassmann permette allo spettatore di cogliere questi piccoli dettagli – fondamentali per poter avvicinarsi al testo di Juan Mayorga e funzionali per cogliere la “sincerità” della comunicazione – attraverso un accurato uso della prossemica. Oltre alla parola, infatti, un altro elemento che parla molto di noi è quello in cui scegliamo di metterci in rapporto con l’altro nello spazio.

Monica Piseddu (Felicia) –Woody Neri (Ismaele)
(ph. Laura Farneti)
Incantevolmente perverso è il modo di porsi della Salinas di Elena Bucci. Lei non si dà quasi mai nella chiarezza della frontalità: si pone sempre “di taglio” rispetto all’interlocutore, perché la sua parola è un taglio. Lei non guarda quasi mai negli occhi: parla come ad occhi chiusi, tutta presa dal piacere cangiante delle parole che sceglie, quasi pregustandone l’effetto sull’altro.
Di lacerante bellezza la Felicia di Monica Piseddu: il suo generoso modo di darsi nell’ingenuità della non conoscenza delle parole e di lasciarsi quindi attraversare con perversa necessità dal maligno fascino di chi questo potere lo conosce e lo usa per sottomettere l’altro, punge gli occhi e il cuore dello spettatore. Perché è capitato almeno una volta anche a noi di esserci infilati in situazioni simili e inconsapevolmente ci siamo resi “golem” di qualcun altro. Il suo monito a chiusura dello spettacolo si incide nello spettatore con il caritatevole graffio del suo sguardo. E ci accompagna. Anche fuori dal teatro.
Inquietante e commovente poter “leggere” nell’Ismaele di Woody Neri tutto il percorso attraversato dall’umano che – progressivamente svuotato di personalità come uno “zombi” – arriva ad essere riempito dalla volontà dell’altro, proprio come un “golem”. Trasformandosi, così, da inconsapevole vittima a carnefice atarassico.

Questo di Jacopo Gassmann è uno spettacolo che avvince come un thriller esoterico, ricco di quella densa e labirintica suspence, che intriga e fa riflettere.
Questo di Jacopo Gassmann è uno spettacolo necessario.

Recensione di Sonia Remoli