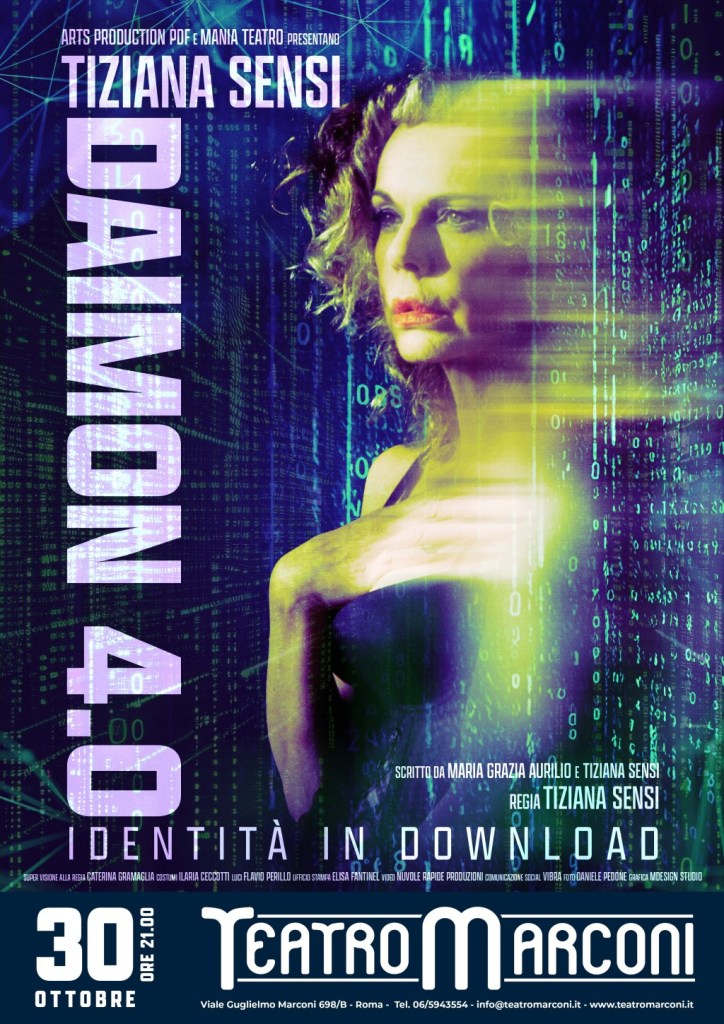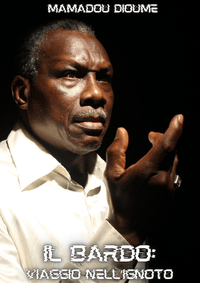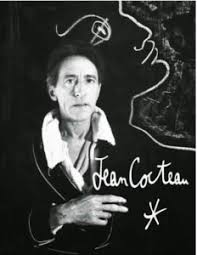TEATRO MARCONI, dal 7 al 17 Novembre 2024

Chissà perché alla fine dello spettacolo – andato in scena ieri sera dal palco del Teatro Marconi – viene quasi da invidiare le tre barbone in scena.
Che strano. Ma perché? Che cosa hanno in più?
Sanno entrare in relazione tra di loro, pur essendo molto diverse.
Sanno ascoltare e interessarsi davvero l’una dell’altra.
Sanno aiutarsi a vicenda nel decifrare la vita.
Insomma: sono la testimonianza di una comunità ben riuscita.
E quando arrivano ad esserne consapevoli anche loro, concordemente scelgono di strappare l’ultimo gruzzolo di soldi.

Mirella Mazzeranghi (Tonta), Angiola Baggi (Regina), Maria Cristina Gionta (Ruvida)
(ph. Tommaso Le Pera)
Uno spettacolo che è una carezza in uno schiaffo (il testo è di Marina Pizzi, la regia di Silvio Giordani) : condizione necessaria per spingerci a riflettere. A non passare oltre.
In fondo non sono mica persone così diverse da noi: sono intelligenti, belle, simpatiche. Brillanti, nonostante la polvere che le ricopre. E, come noi, insicure.
Ma più sfortunate, perché abbandonate e lasciate ai margini: fuori dalla vita sociale “ufficiale”, fuori dalla loro famiglia di origine. A loro è toccata in sorte la realizzazione della paura che assilla tutti noi: rimanere soli dopo una disgrazia, un errore, una disavventura. Essere abbandonati. Per sempre.
Marina Pizzi, l’autrice, scrive un testo davvero fascinoso: dapprima ti sequestra l’attenzione trascinandoti in una realtà surreale, quasi da teatro dell’assurdo. Tanto che le due barbone in scena, Regina e Tonta, ricordano quella tensione di “ansia, freddo buio e vuoto” anche di Vladimiro ed Estragone (“Aspettando Godot” di S. Beckett).

Mirella Mazzeranghi (Tonta), Angiola Baggi (Regina)
(ph. Tommaso Le Pera)
Poi però il loro Godot arriva, anche se non se ne rendono conto subito: è Ruvida. E’ lei quella che desidera più intensamente realizzare una nuova famiglia e quindi un’autentica comunità: una polis.
Una realtà aggregativa con valori specifici e comuni, dove i componenti desiderano il bene comune della collettività stessa. Perché si sentono parte integrante ed insostituibile della comunità. A tal punto da applicare i principi della fratellanza a quelli della collettività extra-familiare. Nasce così un piccolo popolo unito, forte e vigoroso, che si riconosce nella comunità e si prende cura della stessa.
E sembra alludere all’estinzione di questo tipo di popolo l’incipit con cui Regina (un’Angiola Baggi di una luminosa raffinatezza fantasmatica) apre lo spettacolo, quando dice: “Dov’è finito? Non può essere scomparso…”. “E’ una barbarie con i fiocchi” – aggiungerà Tonta. E ancora Regina: “mi piacerebbe cambiare odore”.
Perché se avere un odore significa avere un’identità, volerlo cambiare allude ad un desiderio di evoluzione. Anche Tonta desidera qualcosa di simile (una dolcissima e acuta Mirella Mazzeranghi che al di là del suo definirsi campata in aria come un anacoluto è invece assai consapevole): lei ama i nastri e i lacci. Rossi. Ama i legami, ciò che unisce. Ma che può anche soffocare. Come purtroppo è successo a lei. Eppure vale sempre la pena riprovare, ricominciare.

Maria Cristina Gionta (Ruvida), Mirella Mazzeranghi (Tonta), Angiola Baggi (Regina)
(ph. Tommaso Le Pera)
Anzitutto restituendo il giusto potere alla “parola”: prima magia nelle mani dell’uomo. E’ la bellezza del racconto. E del raccontarsi: “non ho più nessuno da chiamare” – confida Regina a Tonta. Ma inaspettatamente nella loro dualità si fa spazio un terzo elemento. Lei è più giovane, più propositiva, solo apparentemente aggressiva: è Ruvida (una Maria Cristina Gionta efficacemente graffiante).
“Colazione, pranzo o cena qui?” – è il suo modo di presentarsi, di chiedere permesso, di dare un ordine alla tentazione del disordine. Le altre due sono sospettose, sono tentate a chiudersi tra loro appoggiandosi l’una sull’altra. Ma poi Tonta ricorda a Regina che non è efficace “appoggiarsi” a qualcuno, perché se poi quel qualcuno si sposta, si cade e si resta soli. Meglio imparare a contare su se stessi pur stando insieme. E allora con un balzo Ruvida – tenendo a bada il suo fare felino: “Insieme qualsiasi cosa si affronta meglio, no?”.

Mirella Mazzeranghi (Tonta), Maria Cristina Gionta (Ruvida), Angiola Baggi (Regina)
(ph. Tommaso Le Pera)
Ed è sorprendente vedere come partendo da un piccolo nucleo si possa fondare una comunità su basi “solide”.
E il tema della “solidarietà” chiama in causa, oltre alla nostra educazione sentimentale, anche le nostre conoscenze di geometria.
Se infatti la “solidarietà” si fonda sul sostegno reciproco, in geometria ogni parte di un “solido” é tale perché tenuta salda da tutte le altre. Quando non ci curiamo di qualcuno in difficoltà, generiamo una faglia nel solido, che tale non è più. E’ l’aiuto reciproco il cemento del corpo in cui viviamo. Perché “una società solidale” è “una società solida”.
La sapiente e audace regia di Silvio Giordani porta in scena un tema scomodo, affrontato con quella giusta dose di mistero e di ironia, tale da predisporre lo spettatore ad un ascolto più denso.
Quindi solido.
E’ in scena al Teatro Marconi fino al 17 Novembre 2024.

Mirella Mazzeranghi, Maria Cristina Gionta, Angiola Baggi
Recensione di Sonia Remoli