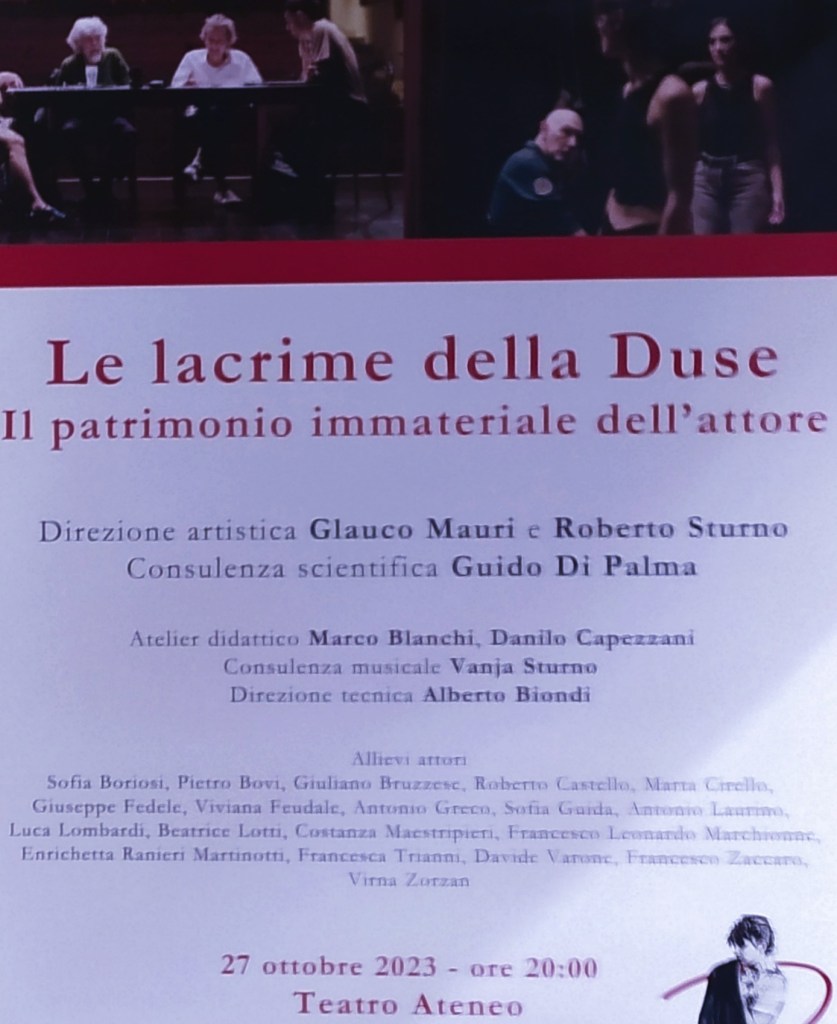dal 2 al 6 Luglio 2025

Travolgente successo al Teatro romano di Ostia per la prima dell’ Edipo re di Sofocle nell’adattamento e regia di Luca De Fusco, traduzione Gianni Garrera.

Luca De Fusco
(ph. Tommaso Le Pera)
Uno spettacolo con Luca Lazzareschi, Manuela Mandracchia, Paolo Serra, Francesco Biscione, Paolo Cresta, Alessandro Balletta – in prima nazionale dal 2 al 6 Luglio – che inaugura la prima edizione del Teatro Ostia Antica Festival- Il senso del passato.

Lo sguardo dello spettatore – incastonato nell’area Archeologica degli scavi e insieme solleticato dall’invitante brezza salata del ponentino romano- inizia a fare esperienza di quella ritualità propria del rapporto tra libertà e necessità, di cui il testo di Sofocle – qui tradotto dal filologo Gianni Garrera – ha cura di descriverci.

Emerge così, dal crepuscolo estivo, una scena sempre più ammiccante e notturna. Modulata in diversi livelli di scale, che ospitano presenze simboliche. Alludenti a identità segretamente celate sotto la formalità borghese di tre cappelli magrittiani e in una testa in gesso velata, sempre di magrittiana memoria, splendida allusione al rapporto dell’uomo con la conoscenza.

Una scena essenziale e simbolica – curata dall’elegante estro scenografico di Marta Crisolini Malatesta, qui artefice anche dei costumi – che richiamandosi alle potenzialità dinamiche insite in una concezione scenica visionaria come quella di Adolphe Appia, va al di là della mera messa in scena di un testo letterario. E si apre al potere della luce come elemento visivo, capace di creare un’atmosfera: mutando assieme alle azioni e alle emozioni dell’attore.
Concezione scenica efficacemente in sinergia con l’estetica surrealista magrittiana, in grado di insinuare dubbi su oggetti, paesaggi ed esperienze della più concreta e banale vita reale, proprio attraverso un maniacale realismo espressivo. Ne scaturisce così un paradosso dall’illusionismo onirico, perfetto per dare ospitalità alla tragedia dell’Edipo re, così come immaginata dallo sguardo registico di Luca De Fusco.

Ecco allora che, furtivamente, lo spettatore si trova calamitato in un misterioso avvio, che coincide con l’introduzione a una dimensione altra. Attraverso un disegno luci atmosferico e narrativo – la cui cura è affidata a Gigi Saccomandi – entra in scena il linguaggio onirico/inconscio della luce insinuante delle ombre, accompagnato dalla misteriosa cromaticità di una tessitura drammaturgica al violino – le musiche sono di Ran Bagno – il cui virtuosismo, incarna quel quid di trascendentale, fascinoso e conturbante.

Complice una creazione video-scenografica che, come uno specchio, rimanda e visualizza surrealisticamente l’habitat inconscio della psiche dei personaggi – le splendide creazioni video sono opera di Alessandro Papa – anche lo spettatore viene gettato nella situazione traumatica della carestia e della successiva peste, in cui è immersa Tebe. Edipo è il re, e a lui le varie aree della sua psiche, nonché la popolazione di Tebe, chiedono salvezza, liberazione.
L’adattamento e la regia di Luca De Fusco partono da qui, per concentrarsi sulla fragilità delle dinamiche conoscitive di Edipo, così simili alle nostre. Non a caso Freud fece della storia di Edipo il fulcro dell’esplorazione delle modalità psichiche umane.

Luca Lazzareschi
L’Edipo di Luca Lazzareschi è magnifico nel suo darsi in una sventurata ostinazione, che però non smette mai di commuoverci. Perché ci appartiene intimamente. Ce ne parla la sua postura così solenne eppure così tormentata: tutta incentrata nella tensione tra il suo ergersi da sapiente, la sua falcata sicura e il suo modo poi di abbassare il capo, proprio di chi viene colto e avvolto dalla confusione e dal dubbio. E lui, anziché restare in questo tunnel di fertili incertezze tutte da esplorare, le scaccia per poi inevitabilmente imbattervisi inconsapevolmente. E poi c’è la sua vocalità: così chiara e piena di ritmo, sicura fino all’impertinenza. E poi arrendevole, mortifera e mortificante.
E ancora, atterrisce e affascina il relazionarsi chiuso di Edipo verso Creonte (qui un efficace Paolo Serra), con il quale non riesce ad allacciare un equilibrio di posizioni divergenti. Edipo è il primo detective nella storia del romanzo giallo – come la lettura registica di De Fusco sa sottolineare – ma la sua capacità di indagine è efficace solo formalmente: Edipo sa chiedere attraverso un editto, sa da chi può farsi aiutare per ricavare indizi dalle tracce, ma poi non ce la fa a scendere ad analizzare le loro profondità.

Paolo Cresta (secondo Nunzio, secondo Corifeo) – Luca Lazzareschi (Edipo) – Alessandro Balletta (terzo Corifeo) – Francesco Biscione (primo Corifeo)
Incantevolmente struggente è la visualizzazione che di questo concetto ci offre la regia di De Fusco, quando sceglie di far prendere in mano ai tre Corifei (Francesco Biscione, Paolo Cresta, Alessandro Balletta) la testa di gesso velata. Per poi svelarla.
E’ una tendenza tutta umana, infatti, quella per cui ci si affanna nella curiosità insaziabile di sapere, per poi rimanere sorpresi nello scoprire che siamo capaci di sopportare solo piccole dosi della verità che ci si mostra.

Manuela Mandracchia (Giocasta) – Luca Lazzareschi (Edipo)
E’ l’effetto che ogni volta l’oracolo ha su coloro che a lui si rivolgono, come ad una sorta di arcaico psicoanalista, quando sono in una crisi tale che non sanno da dove cominciare a dipanare la nebbia dei dubbi. Ad esempio quando Edipo scopre di essere stato adottato: l’oracolo non risponde alla sua domanda su chi sono i suoi genitori biologici ma gli dice che è importante che lui consideri – e quindi metta in relazione con le sue aree psichiche migliori – anche la realtà che dentro di sé esiste una tendenza che lo spinge ad uccidere suo padre, per poi sostituirlo nel ruolo di marito con la madre.
Ma Edipo è così turbato da non riflettere bene sul significato metaforico del consiglio. Lo prende invece alla lettera e crede che la cosa migliore sia sfuggire dai genitori adottivi. Così qui: quando Edipo manda Creonte a chiedere all’oracolo come fare per liberarsi dalla peste e poi ascolta il responso, inizia a fare fatica a rimanere concentrato sulle prime testimonianze. Perché sente che si sta avvicinando ad una verità grande, difficile da accogliere e da mettere in relazione con la propria autostima. Sente, che proprio nell’indagare, è se stesso che sta cercando. Ed è di straordinaria bellezza tragica.

Luca Lazzareschi (Edipo, Tiresia, Servo di Laio, Nunzio)
L’acme del disagio si raggiunge con Tiresia – qui reso attraverso una seducente ed efficace proiezione video, che ne fa una creatura volatile che dondola imprigionata in una gabbia. Lui che era un esperto dell’ arte divinatoria analizzando il comportamento, il canto e la direzione del volo degli uccelli . Assai avvincente la sua vocalità: dalla musicalità cantilenante distorta, vagamente gracchiante eppure così divina.
Nella profonda lettura di De Fusco anche Tiresia – così come il Servo di Laio e il Nunzio, essendo coloro che a qualche livello conoscono la verità – divengono aree diverse della psiche di Edipo, le quali entrano in tensione con la prepotenza del suo ”io”. Che – come sosteneva Freud – “non è padrone in casa propria”. Infatti la tensione con l’area psichica rappresentata da Tiresia diviene così ingombrante, da far arrivare Edipo a sospettare un complotto contro di lui da parte dello stesso Tiresia e di Creonte.

Luca Lazzareschi (Edipo) – Manuela Madracchia (Giocasta)
Non lo convince a desistere dall’andare ciecamente avanti nella sua ricerca, neanche l’approccio di Giocasta (qui una suadente Manuela Mandracchia, meravigliosa nube cumuliforme), che versa nell’orecchio di Edipo il dubbio che in fondo gli oracoli non sono poi così puntuali. E che preferibile per lui sarebbe, scegliere “il meglio” piuttosto che “la verità”.

E così Edipo impara, e noi con lui, che nessuno in quanto “figlio” può essere padrone delle proprie origini. Tutti noi, sosteneva Jacques Lacan, veniamo al mondo “a mollo nel linguaggio dell’altro”. E il nostro primo “altro” sono i nostri genitori, dai quali Edipo non eredita altro se non un abbandono e un (mancato) infanticidio. Eredità che ripeterà, non accettando di “conoscere se stesso” nel bene e nel male, così come di non poter conoscere tutto. Tra l’altro, sostenere massicce dosi di verità non è affatto semplice: Jung diceva ai suoi pazienti psicotici che “è bene non aprire tutte le porte: quello che può uscire, rischia di catturare la mente senza restituirla”.
Ma se è vero che per Edipo, e per noi umani, fare esperienza di “libertà” significa conoscere se stessi nel bene e nel male ed accettarsi, dietro ad Edipo c’è anche “il destino” che parte dalla violenza subita da suo padre da parte dei Dioscuri di Tebe e poi a sua volta ripetuta da Laio su Crisippo.
E’ per questo che l’oracolo dice a Laio che, se avrà un figlio, ne verrà ucciso e diverrà lui marito a sua madre. E Laio anziché decifrare questo messaggio metaforico, pensa di evitarne gli effetti dapprima proteggendo i suoi rapporti e poi consegnando il neonato affinché venga ucciso. Edipo sopravviverà e quando, scoprendo di essere un figlio adottato ne andrà a chiedere informazioni all’oracolo, lui stesso cadrà nello stesso errore di non decifrare l’oracolo ma di sfuggirne gli effetti interpretandolo letteralmente. E così, sconvolgendo i rapporti “sociali” di parentela, Edipo – che aveva risolto l’enigma della Sfinge – finirà per darà origine lui ad altri enigmi, del tipo: “chi è colui che ha un padre che è anche un suocero? Chi è colui che ha una madre che è anche una moglie? Chi è colui che ha fratelli anche come figli? Tanto che, nelle “Fenicie”, Seneca mette in scena un Edipo vecchio e disperato a cui fa dire: “Se io da qui raccontassi ciò che ho fatto della mia famiglia, proporrei enigmi più inestricabili di quelli della sfinge”.

(ph. Claudia Pajewski)
Accattivante lo sguardo registico di Luca De Fusco nel suo scegliere di indagare, fino a visualizzare negli occhi dello spettatore ciò che Edipo tende ad allontanare da sè.
Lui stesso, il regista, un detective nel consultare e interrogare il passato.
Scoprendo di essere capace di cura e di responsabilità nel presente e nel futuro, così da tenere alta la consapevolezza di chi siamo, da dove veniamo e fino a dove abbiamo la possibilità di spingerci.
Per non perdere niente di ciò di cui è fatta la nostra vita. Niente e nessuno.

Da questo sguardo di cura sul passato che si riflette sul presente, prende forma anche il desiderio della realizzazione del Teatro Ostia Antica Festival-Il senso del passato: il Festival che a Roma ancora non c’era e che è stato fortemente immaginato da Luca De Fusco – ci confida Il Presidente della Fondazione Teatro di Roma Francesco Siciliano nel suo discorso di apertura, alla prima di “Edipo re”. Un nuovo inizio a cui la comunità romana ha risposto con grande entusiasmo.

Dopo i grandi successi dei primi due appuntamenti
“’Antigone di Mendelssohn” direttore Francesco Lanzillotta
e
“Edipo re” per l’adattamento e la regia di Luca De Fusco
il Teatro Ostia Antica Festival – Il senso del passato
prosegue con
“Antigone” di Jean Anouilh per l’adattamento e la regia di Roberto Latini.
il 18 e il 19 Luglio 2025


Recensione di Sonia Remoli