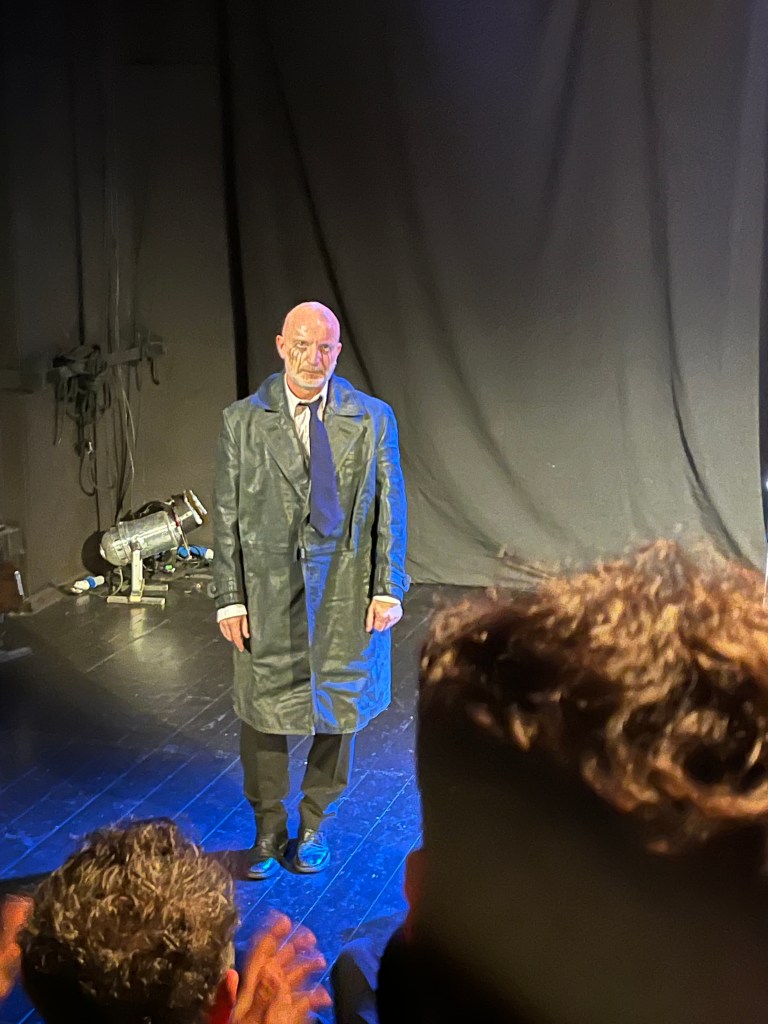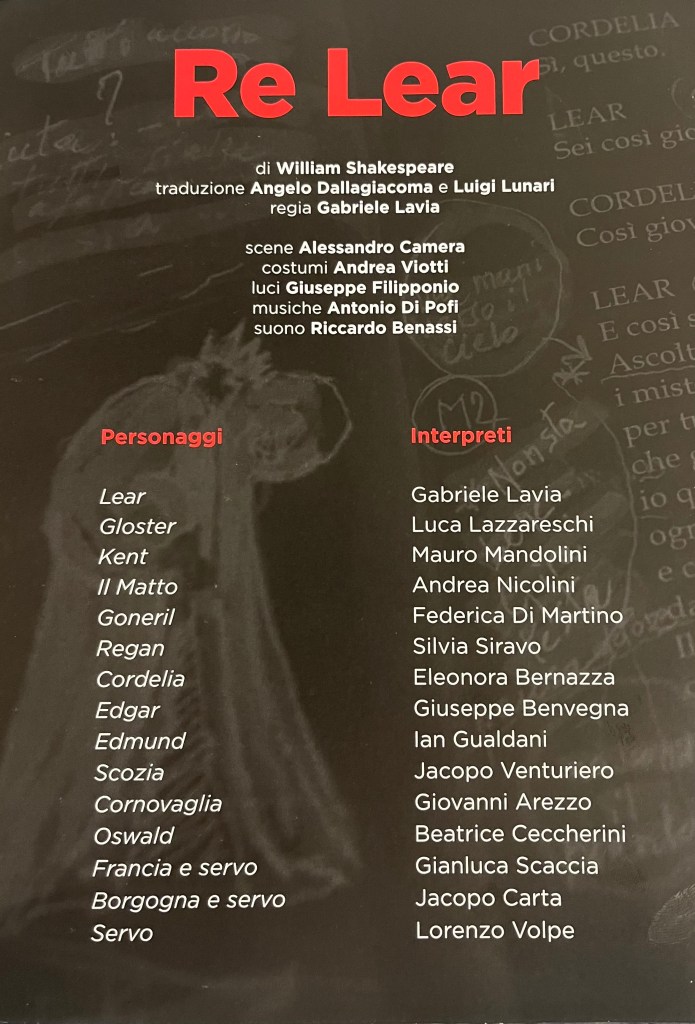TEATRO ARGENTINA, dall’8 al 19 Gennaio 2025

Parole di gioia per il rientro in Italia della giornalista Cecilia Sala il Presidente della Fondazione del Teatro di Roma Francesco Siciliano ha desiderato condividere con il pubblico presente ieri sera al Teatro Argentina, in occasione della prima dello spettacolo che inaugura la programmazione dell’anno 2025: “Tre modi per non morire – Baudelaire, Dante, i Greci” con Toni Servillo, tratto dai testi dello scrittore e traduttore Giuseppe Montesano.
Con piacevole sorpresa, prendendo posto in sala, il pubblico non ha potuto non apprezzare la cura dell’essere accolto in una platea rinnovata, capace di offrire un’esperienza di partecipazione ancor più coinvolgente. Un gesto di attenzione per preservare e valorizzare un patrimonio irrinunciabile com’è quello rappresentato dal Teatro: “un luogo aperto, dove la verità non ha paura di mostrarsi”. In tutta la sua complessità. Come i Greci ci hanno insegnato, ci ricorda un fulgido Toni Servillo.
Proprio loro che hanno inventato un pensiero che si fa veicolo di ”un’immaginazione attiva” capace di tenere insieme, come passi di un’unica danza, le dualità esistenziali di corpo-mente, bene-male, uomo-mondo. Una danza, i cui cambi di passo sono resi da Toni Servillo con quel fervore ieratico che attraversa i suoi “ma …”. Così come certi suoi “quando ….” e alcuni “se…”. E che fanno di lui, colui che, al pari dei Greci, riesce a sostenere lo sguardo sul come la nostra umanità tende ad essere travolta dall’infelicità e dalla miseria. Ontologicamente in bilico su un piano inclinato: condizione esistenziale efficacemente resa dalla “lingua di scena” sulla quale è costretto a muoversi l’uomo-Servillo.
E di questa torbida luminosità umana il Teatro, non solo greco, vuole e deve continuare a parlarci, per consentirci di guardarci allo specchio. Concetto, questo, sul quale viene concertata con sublime efficacia la drammaturgia del disegno luci (curato da Claudio De Pace), nonché quella del disegno musicale.
Perché solo riuscendo a guardare in faccia le nostre mostruosità esistenziali, saremo in grado di ricavarne una consapevolezza poietica: capace di dare vita cioè alla bellezza creativa, che ci è stata donata come un fuoco. E che chiede di essere continuamente “riattizzato” per poter produrre fecondamente poesia: da condividere insieme, “come pezzi di pane”.
Perché è così che la vita può essere educata a preferire il gusto per la costruzione e la condivisione di “un nostro”, piuttosto che di “un mio”. Come ci insegna anche il mito platonico della caverna, rievocato da un Toni Servillo denso in fervore, abile nel disporre di quel giusto mezzo che permette di raffinare un discorso senza renderlo meno comprensibile.
Perché è di vitale importanza non lasciarsi infatuare da quelle ombre che, come subdoli fantasmi, ci trattengono a rimanere dentro la caverna: isolati e chiusi in noi stessi. Apparentemente al sicuro ma in verità assediati dal peggiore dei mali: la noia.
Vita è invece uscire dalla zona di confort della caverna – luogo che acutamente l’autore Giuseppe Montesano attualizza nel suo dialogo immaginario con Baudelaire attraverso il ricorso a quell’espressione spesso di eccessiva tutela, che a tutti risulta così familiare, qual è quella del “è per il tuo bene” – per toccare e lasciarsi toccare dalla compassione bruciante per l’Altro.
Con il quale non dobbiamo lasciare che si interrompa un fertile dialogo, perché vita é che la bellezza possa anche scontrarsi con la cruda realtà, come s’infiamma nel farsi testimonianza il Servillo-Baudelaire.
Perché ognuno di noi è “una moltitudine” e non un egocentrico “io”. Ma siamo spesso, come possiamo scoprire specchiandoci nell’esperienza esistenziale di Dante, “un’aiuola che ci fa tanto feroci”. Sebbene cioè resi partecipi di una realtà di bellezza, spesso preferiamo ridurre questa condivisione ad una trappola per topi, dove ciascuno vive “contro”, e non “con”, l’altro. Dove trova spazio solo l’egoismo insaziabile che scatena la guerra di tutti contro tutti.
Dove una subdola ferocia ci porta egoisticamente a guardare solo al nostro misero spazio della caverna, o ad essere “ignavi”: tiepidi, fino all’indifferenza totale alla partecipazione, al coraggio. Scegliendo di non fare né il bene, né il male. “La loro indifferenza impaurita è imperdonabile” – ci ricorda Dante – tanto che a costoro viene negata la morte, dono riservato solo a chi ha vissuto spendendosi per un bene comune.
Meglio allora – si sporge a dire Dante – un Ulisse che ha errato mettendo in pericolo la propria vita alla ricerca della virtù e della conoscenza. Meglio chi, come lui, si spinge verso l’ignoto, verso il nuovo. Come coloro che, nel cuore dell’Inferno, abitano un’aiuola “di tenere labbra”: quelle degli amanti. Dante si scopre a non riuscire a condannarli. E sviene. Come preda di una metamorfosi interiore. Che lo porterà alle soglie del paradiso, fino alle “stelle”. Ma non è, il suo, un arrivo: piuttosto un invito a una nuova rilettura. A un nuovo viaggio. Perché la forza dell’amore, della partecipazione, della relazione, è una forza che ci abita e che ci spinge a fare di ogni arrivo una possibile nuova partenza.
Quella di Toni Servillo si rivela un’interpretazione fiammeggiante, capace di appiccare fertile fuoco creativo sullo spettatore. Così come la sinergia di testi che dà forma a questo adattamento sortisce l’effetto provocatorio e insieme balsamico di un attuale “conosci te stesso”. Un accorato invito, quello dell’autore Giuseppe Montesano, a non smettere di interrogarci su chi davvero siamo, specchiandoci nel confronto con le vite altrui – qui, quelle di Charles Baudelaire, di Dante Alighieri e dei Greci – così da trovare una risposta, “un riflesso di conoscenza, un invito al coraggio”. E giungere, con partecipazione commossa, a riscoprirci “uomini”. Capaci, se insieme, di fare della nostra mostruosa finitudine una ricchezza in continua trasformazione.
Uno spettacolo prezioso per inaugurare un Nuovo anno di possibilità, da esplorare lasciandosi toccare da quegli attimi “capaci di far apparire il nuovo, che capovolge le parvenze del mondo”.
Recensione di Sonia Remoli