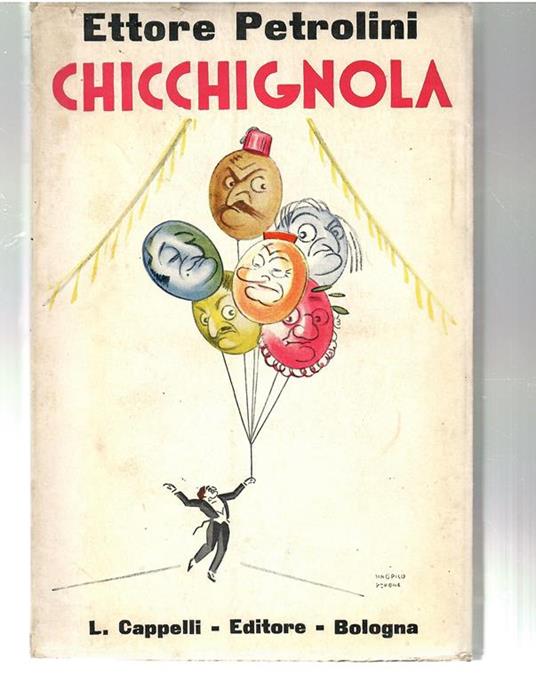DOMUS AUREA – MOISAI 2024 Voci contemporanee in Domus Aurea – 5 Ottobre 2024 –

“Le storie delle donne non possono essere solo storie invisibili”
Quale miglior luogo della Domus Aurea si rivela simbolicamente più appropriato per rappresentare questo lussureggiante racconto di Anna Banti, contenuto nella raccolta “Le donne muoiono” (1951) ?
Forse nessun luogo come questo è la testimonianza pulsante di cosa rappresenti una damnatio memoriae, un esilio che qui in “Lavinia fuggita” prende la forma dell’ “interrare” il ricordo di una donna eccessivamente dotata in capacità conoscitive.

Anna Banti
Tutta la produzione di Anna Banti, in verità, si nutre del grande tema della solitudine della donna che, alla ricerca di riconoscimento nel mondo degli uomini, si ritrova protagonista di umiliazioni. Ma, a volte, anche di riscatti.
E’, per certi versi, anche la solitudine che la stessa Banti ha cercato di fuggire “ri-nominandosi” (Anna Banti è uno pseudonimo di Lucia Lopresti) e ri-convertendosi ad un genere letterario (la narrativa) diverso da quello al quale lei avrebbe voluto dedicarsi e nel quale avrebbe desiderato essere riconosciuta: la critica d’arte.

E così anche Lavinia, la protagonista principale di questo racconto – che Cesare Garboli definì il più bello di tutto il Novecento – è costretta a fare esperienza di una “solitudine di merito” tipicamente femminile.
Fin da giovanissima infatti il suo brillare conoscitivo venne oscurato attraverso allontanamenti. Era dotata, ad esempio, di una particolare attitudine nel riuscire “a balzare” da uno strumento musicale all’altro: “che ci vuole?”- era solita rispondere a chi ne rimaneva incantato. Come per effetto di un sortilegio, infatti, ogni difficoltà si scioglieva al suo cospetto.

Ma anziché curarsi di valorizzare questa sua eccellenza – proprio lì all’Ospedale della Pietà dove si studiavano canto e musica – “la interrarono”, allontanando Lavinia dallo studio dove eccelleva, per confinarla tra le scartoffie di un’attività da maestra.
L’urgenza di comporre musica però – quando è davvero un’autentica passione – non trova argini: come si fa “a star zitti se ti chiama qualcuno che ti vuole bene “. E così’ Lavinia iniziò ad inserire dapprima, a sostituire poi, le sue partiture nelle partiture altrui: quelle che si doveva limitare a trascrivere. Consapevole che mai le avrebbero permesso di comporre musica, se non di nascosto. Fino a che una sua partitura arrivò nelle mani di Don Antonio Vivaldi. Fu la fine, o meglio, l’inizio di una nuova vita.

Perché proprio quel giorno in cui tutti all’Ospedale si usciva per andare “a merendare”, si rivelò un giorno di appassionati e appassionanti incontri: chi si sposò, chi s’innamorò e chi come Lavinia ricontattò le proprie origini, fino ad allora sconosciute. E così quando Don Antonio Vivaldi le intimò: “venga Lavinia !” – lei, come nel mito accadde a Dafne inseguita, fu dalla “sua terra d’oriente” accolta nel proprio seno. E lì, dal luogo dove la giovane disparve, crebbe l’alloro.
Ieri sera in Domus a scegliere di riportare l’attenzione su questo tema della solitudine femminile è stata Michela Cescon: attrice pluripremiata, produttrice e direttrice del Teatro di Dioniso di Torino.

E’ lei che ha avviato il racconto concertandolo con il canto e la musica di Tullio Visioli e di Livia Cangialosi. La sua interpretazione del testo della Banti – di una raffinatezza deliziosamente succulenta – è reso con una tavolozza di colori vocali, che acquistano una definizione a tutto tondo grazie ad una gestualità generosamente aperta ad un puntinismo cromatico da commedia dell’arte. Efficacissimo nel rendere il ventaglio di tonalità delle pennellate stilistiche che danno corpo alla scrittura della Banti, così ricca in lirismo metaforico e in scavo psicologico.

Gli intervalli di musica e di canto – oltre a definire il carisma di alcuni passaggi decisivi della narrazione – disegnano, con la complicità della Musa Polimnia, come nuove armonie ricche in sacralità. Intellegibili non solo attraverso l’ascolto ma percepibili ad un livello più alto, dove la libertà riscopre una nuova melodia fatta di continui inizi.
Lo spettacolo è stato dedicato a Eleonora Duse (1858 – 1924) – nell’occasione dei suoi 100 anni dalla morte – per la vibrante sfrontatezza nell’affrontare la vita così ben rappresentata dalla sua postura con le mani sui fianchi. Postura con la quale la Banti caratterizza anche la sua Lavinia .

Michela Cescon, Tullio Visioli, Livia Cangialosi
Recensione di Sonia Remoli