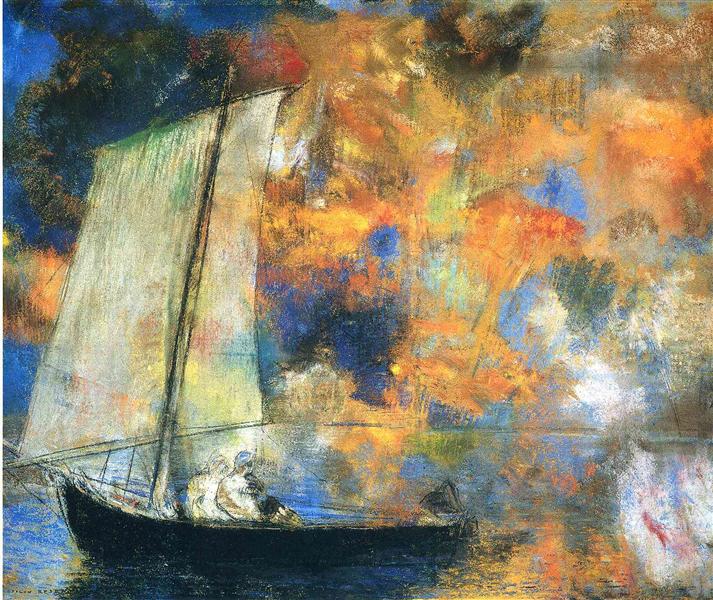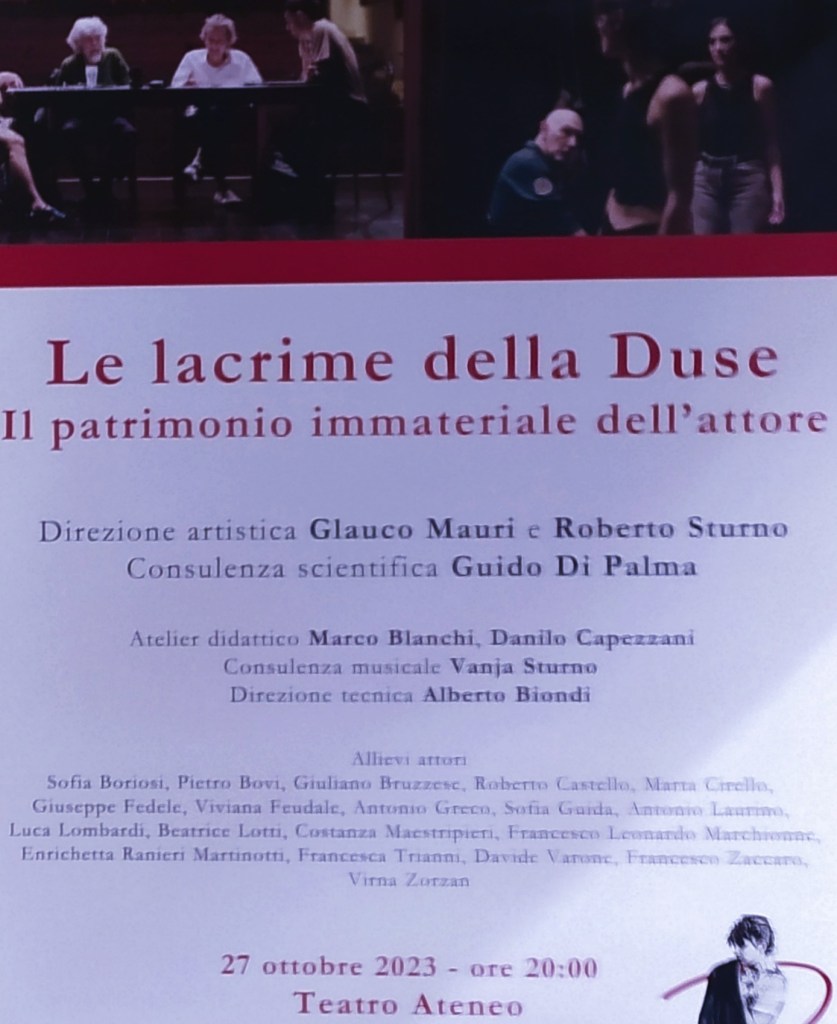Terza edizione del Festival “Teatro delle Migrazioni”
dal 1° al 3 Luglio 2024, presso il Nuovo Teatro Ateneo
Sapienza Università di Roma

NUOVO TEATRO ATENEO, 3 Luglio 2024

L’Ultimo Icaro
drammaturgia e regia di Pietro Floridia
con Donatella Allegro, Anna Luigia Autiero, Younes El Bouzari
al drone Francesco Lombardi
scenografie Luana Pavani
musica Stefano D’Arcangelo
videodisegni Sara Pour
Quanto siamo intimamente legati al desiderio di volare ?
Cosa siamo disposti a fare per assecondare questa spinta ontologica così legata al nostro desiderio più profondo di libertà’ ?
Una libertà che così magnificamente trova espressione nell’ebbrezza del volo e che non sembra essere sfiorata da una spinta centripeta alla sicurezza, che pure ci abita?
Lo spettacolo portato in scena ieri sera al Nuovo Teatro Ateneo dell’Università Sapienza di Roma a conclusione della terza edizione del Festival “Teatro delle Migrazioni”, ha rappresentato un tentativo di sublime efficacia nel rendere la labirintica rete di punti di vista su questo folle e necessario desiderio: quello del volo.
Lo sguardo drammaturgico e registico di Pietro Floridia sceglie di impostare la narrazione con un taglio giornalistico: si parte da un’intervista “on air” che dà avvio alla ricostruzione della vicenda – al limite tra una fake e una teoria da sito complottista – che vede protagonista un cosiddetto “arabo volante” presunto “veicolo” per l’ingresso clandestino di migranti. Taglio giornalistico successivamente integrato arricchendolo – e quindi contaminandolo – con una molteplicità di punti di vista, resi registicamente con un’efficace ed avvincente tecnica, anche cinematografica, di suspence.
Suspence che si origina dalla scrittura drammaturgica per arrivare a declinarsi nella multiforme suggestione di proiezioni visive – anche specchio di dinamiche interiori – raffinatamente integrate alla liricità di un evocativo disegno luci.

Pietro Floridia
Ed è attraverso la bellezza della struggente malinconia del canto-racconto di Joseph “l’arabo volante” (un Younes El Bouzari la cui voce sa farsi cielo e corpo) che arriviamo a fare esperienza di quanto la nostra natura umana educata -quando non obbligata- a muoversi dentro confini, patisca l’effetto-gabbia.
E poi, è ancora attraverso l’atto d’amore, espressione di sconfinata vitalità umana, che possiamo sperimentare qualcosa di simile all’ebbrezza del volo. Così come nell’attività artistica. Ma in tutte queste modalità espressive sembra non essere possibile rifuggire da un desiderio umanissimo di confinamento, di manipolazione.
Labilissimo è infatti il limite tra la ricerca della libertà e la tentazione alla sopraffazione. E la regia di Pietro Floridia sa come visualizzare – e quindi veicolare emotivamente seducendo la mente – questa tensione esistenziale nella quale, volando, rischiamo di finire bruciando noi stessi o l’Altro.
E’ l’urgenza che abbiamo di “lasciare un segno” che fa sconfinare la nostra esperienza di volo, di libertà.
E’, ad esempio, il tratto che l’artista (un’accattivante Anna Luigia Autiero) traccia durante l’atto d’amore con il suo modello-amante Jouseph, intenta prioritariamente a portare a realizzazione il suo ciclo di quadri dedicati all’esperienza del volo. Splendida qui la drammaturgia dei corpi, che ci racconta con sensuale lacerazione come l’atto d’amore sia non tanto “un rapporto” sessuale quanto piuttosto un “corpo a corpo” tra un fluido incontrarsi e un confinante mettere l’altro “in croce”.
E’ il desiderio di sapere che l’antropologa (un’efficacissima Donatella Allegro) sente di assecondare per un’urgenza di conoscenza sempre più esigente. E che poi prende la forma (il segno) di un dossier sul caso dell’ “arabo volante”. Desiderio del quale riesce anche a contaminarsi, abbandonandosi nell’adesione al sogno di volare con Jouseph.
Riuscire a instaurare un fertile conflitto dialettico tra queste due tendenze che ci abitano, quella verso la libertà e quella verso il controllo, può rendere il nostro stare al mondo un’esperienza interessante e feconda. Perché “il confine” non è solo il luogo che separa ma anche “la soglia” sulla quale ci si può incontrare. Così da evitare il più possibile la degenerazione dannosa in rapporti di simbiosi o di sopraffazione di varia natura.

E’ un invito ad una riflessione oggi più che mai necessaria, questa sollecitata con grazia inquietante dal teatro di cui si fa testimone il collettivo dei Cantieri Meticci, che accoglie e restituisce i temperamenti della geografi umana di artisti provenienti da 30 diversi Paesi del mondo.
Che elegge a luoghi di interesse quei luoghi che ancora tendono a rimanere troppo inesplorati: le periferie, le scuole, i centri di accoglienza, le piccole biblioteche di quartiere, le parrocchie. Fucine di storie di un’umanità desiderosa di incontrarsi “sulla soglia” con le realtà centrali della città, così da poter dare vita ad un’inedita Agorà. Perché ciò che ci risulta estraneo, “straniero” può essere accolto anche come un “ospite”.
Perché saper volare significa anche saper atterrare, cioè far sì che con la terra si realizzi un incontro e non un drammatico scontro. Come Abbās ibn Firnās, inventore arabo del primo aereomobile nel IX sec. ci ha insegnato: solo cercando di integrare e di accordare tra loro ali e coda si può davvero volare.

Recensione di Sonia Remoli