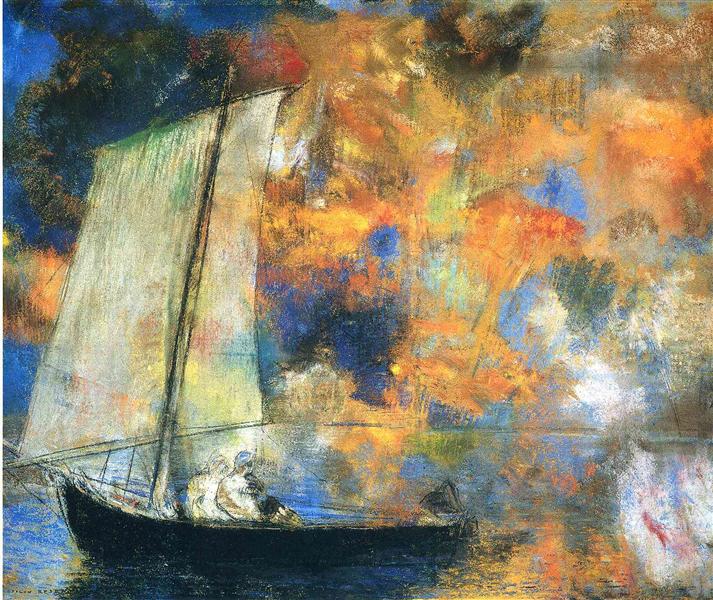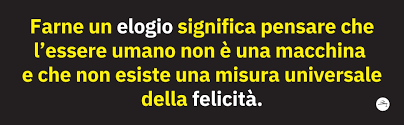TEATRO ELETTRA , 8 Luglio 2024
Terza edizione “Re(s)print” – L’Estate Elettra , 1 -15 Luglio 2024

Quanto bisogno abbiamo di vivere “un incontro” che per anni abbiamo solo immaginato?
Quanto bisogno abbiamo di rivelare, chiedere e sentirci rispondere qualcosa di univoco, al di là delle mille ipotesi che abbiamo formulato nel tempo?
Anche su questo ci porta a riflettere il penetrante testo di Antonella Antonelli, autrice dello spettacolo di cui Massimiliano Milesi cura acutamente la regia, andato in scena ieri sera nel piccolo gioiello del Teatro Elettra, ad un passo dal Colosseo.

Massimiliano Milesi
La Antonelli, che con Milesi e la loro Compagnia “TeatroDaViaggio” condivide la passione e quindi il lavoro di ricerca pluriennale sulle opere di Carlo Goldoni, da queste si è lasciata attraversare fino ad arrivare ad interrogarsi sulla stessa personalità del celebre commediografo. Nello sguardo di Antonella Antonelli confluisce infatti oltre alla prospettiva di attrice e a quella di dramaturg della compagnia, anche quella di psicologa clinica.

Antonella Antonelli
E se è vero, come è vero, che è la capacità travolgente e sconvolgente di certi “incontri” a dare forma alla nostra vita, allora si può convenire che fosse necessario immaginare e dare realtà teatrale ad “un incontro” tra le due donne più amate dal Goldoni: sua moglie Nicoletta Connio e la presunta amante Maddalena Marliani, musa e prima interprete della Mirandolina de “La locandiera”.
E’ la Connio (qui resa da Barbara Bergonzoni) a sentire l’esigenza di contattare la Marliani, per chiederle di recarsi da lei, all’indomani della morte del marito. Ed è sulla qualità del suo attendere, resa mirabilmente dalla postura e dal sentire degli occhi, che si apre lo spettacolo di Milesi.
Appassionato si rivela l’incontro tra le due femminilità così diversamente esuberanti: l’una, la Marliani, visibilmente vibrante; l’altra, la Connio, decisamente più composta ma parimenti partecipe in emozione.
E la sensazione che arriva allo spettatore nel corso della rappresentazione è qualcosa di simile ad un fertile ricongiungimento di due costitutive parti del femminile.

La moglie di Goldoni non può tacere la sorpresa nel vedere l’amante del marito senza l’abituale coronamento seduttivo dei lunghi capelli. “Pesavano” – le risponde con intensa profondità Maddalena.
L’ Antonelli autrice – qui anche interprete di densa sensibilità nel ruolo di Maddalena – semina con questa allusiva risposta il primo dubbio e quindi il primo indizio che fa immaginare allo spettatore che una qualche ricerca di trasformazione interiore sia già in atto anche in Maddalena.
Lei stessa lasciata da Goldoni, come le altre amanti di cui amava circondarsi, anche a causa di un disturbo di ciclotimia: un’estrema instabilità dell’umore che lo faceva scivolare in atteggiamenti depressivi per poi risalire al suo consueto ottimismo. Così ci rivela l’Antonelli nelle sue note d’autrice.
“Ma voi non siete stata come le altre” – le rivela la moglie Nicoletta, restituendole quell’identità unica e necessaria che aveva così bisogno di contattare Maddalena. “Lui non ha mai smesso di pensarvi e di riconoscere il vostro talento, fino agli ultimi giorni: voi siete stata un sostegno per lui, non l’avete usato. Per questo io, di voi, non sono mai stata gelosa”.
Nicoletta infatti, sebbene avesse sempre accolto con paziente disponibilità le incursioni del marito nel femminile delle altre donne, al femminile di Maddalena sente il bisogno di congiungersi, riconoscendo a qualche livello in esso il sano completamento del suo femminile. Esclusivamente di natura comprensiva, prudente e devota, in omaggio al quale il Goldoni scrisse la commedia “La buona moglie”. Ma solo conoscendola di persona Nicoletta scopre che Maddalena chiama il “suo” Carlo, Osvaldo. Nome che Nicoletta sapeva che il Goldoni detestasse, ma di cui ora scopre si lasciasse “rinominare” in esclusiva da Maddalena.

Ecco allora che, attraverso il potere del “racconto”, l’Antonelli rende possibile una fertile contaminazione tra le due femminilità, a cui la regia di Massimiliano Milesi sa donare corpo con guizzo naturalistico. Entrano così nello spazio scenico – spazio della memoria delle due donne – i compagni complici e rivali di tante giornate e di tante avventure artistiche ed umane. Sono Arlecchino (Alessio Serafini), Brighella (Giovanni Pratichizzo), il Giovane Innamorato (Manuel Kilani), la Giovane Innamorata (Maria Elena Pagano), il Poeta (Marco Laudani), Silvestra (Laura Nardi), Teodora (Maria Grazia Bordone) e il Goldoni (Fabio Di Valentino).
Molto interessante il lavoro sulla prossemica – opportunamente calibrato per un palco così “intimo” come quello del Teatro Elettra – nel quale è riuscita ad esprimersi un’appassionata sinergia attoriale.
Grazie alla quale noi del pubblico riusciamo a condividere il prender forma di un personaggio così moderno come quello di Mirandolina, al quale il Goldoni si era ispirato conoscendo Maddalena. Ciò che non immaginava però è quanto la stessa fosse disposta ad osare, non solo nell’interpretarlo – consapevole di rischiare di non assecondare il gusto del pubblico e della morale vigente – ma anche contribuendo alla stesura stessa del testo, con sempre accresciuta audacia.
Audacia decisamente non ipocrita in quanto dichiarata, anche all’interno della compagnia, alla luce del sole e non garbatamente alle spalle: “Ma io sono l’amante del Goldoni !” – soleva rispondere alle insinuazioni dei compagni di lavoro.
Quell’audacia di cui ci parlano le volute di quel filo rosso di cui Maddalena si adorna il collo e i piedi, segno – e non solo oggetto – di quell’amore per se stessa che solo in quanto tale poteva essere così generoso verso l’Altro. Segno e non solo oggetto di quel suo desiderare, a cui si è sempre mantenuta fedele. Disponibile ad accoglierne tutti i possibili disequilibri; proprio lei che per così tanto tempo si era allenata invece a curare il proprio equilibrio fisico, così come richiesto ad una ballerina di corda.
Ma sarà proprio questa accoglienza verso il disequilibrio ontologico al nostro desiderare a restituirle la consapevolezza dell’instabilità della vita e delle relazioni che la tessono: “occorre vivere il momento !”. Stabile, può e deve essere la nostra follia all’interno del teatro della vita.

Un testo e una regia – questi di Antonella Antonelli e di Massimiliano Milesi – che ci parlano con poetica bellezza del bisogno, che tutti ci accomuna, di essere riconosciuti e quindi apprezzati nella nostra unicità. E dell’esigenza, sempre più consapevole, che tale unicità sia la risultante di un lavoro di ricerca su noi stessi aperto ad accogliere – e quindi ad “incontrare” in fertile “dialogo” – parti differenti e in continua evoluzione di noi stessi.
Un’evoluzione esistenziale non meno necessaria dello scardinamento della fissità delle parti attoriali, di cui si avvertiva così tanto il bisogno nel teatro goldoniano.

Recensione di Sonia Remoli