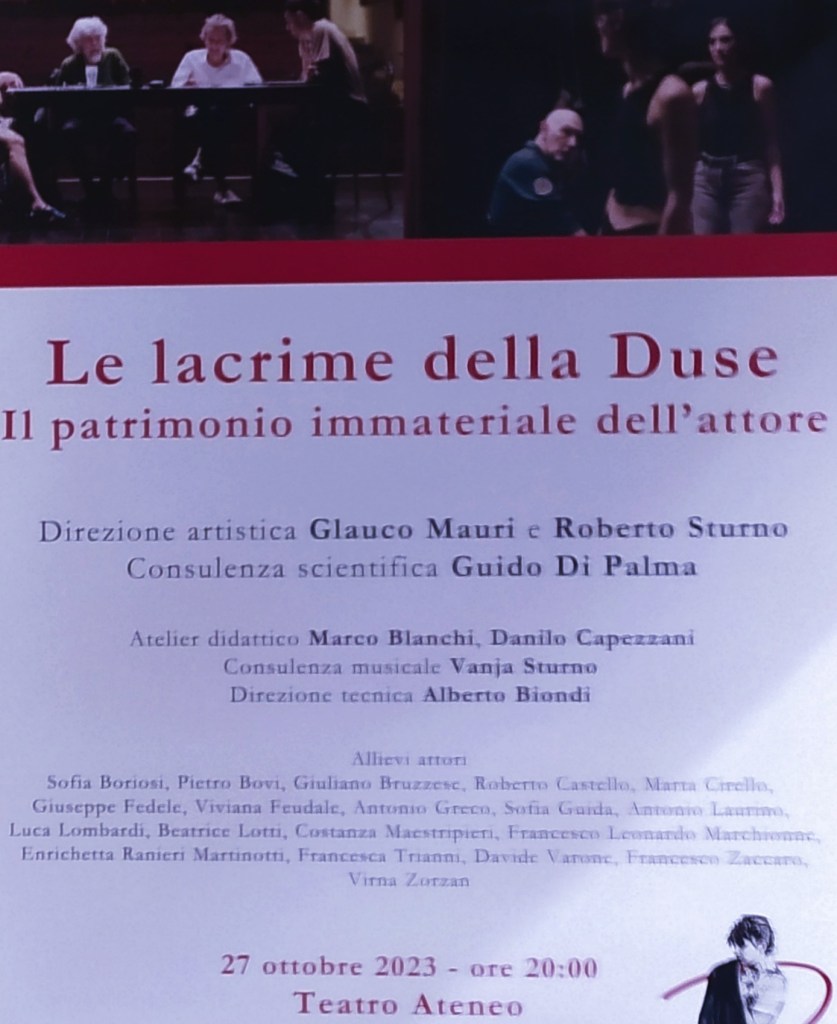TEATRO GHIONE, dal 9 al 12 Novembre 2023 –

Rievocare per non dimenticare.
Questo l’alto valore della scelta etica, prima ancora che estetica, di Caterina Costantini nel riproporre dopo 38 anni dal primo allestimento l’adattamento di Annibale Ruccello de “La ciociara” di Alberto Moravia con la regia di Aldo Reggiani. Lo spettacolo, ieri sera al debutto, resterà in scena al Teatro Ghione, in anteprima nazionale, fino al 12 novembre p.v.
Le atrocità e gli orrori della guerra infatti, temi centrali del testo originale, purtroppo sono ancora attualissimi.
È davvero molto necessario allora ricordare che cos’ è la guerra e cosa diventano gli uomini in guerra. Perché – come sosteneva Primo Levi – “chi dimentica il passato è costretto a ripeterlo”.
E seppure è innegabile che la guerra acutizzi il nostro ancestrale e prepotente istinto alla sopraffazione, è importante non smettere di desiderare di voler imparare a diventare capaci di amare. Perché l’amore s’impara: non è un sentimento che riceviamo per natura.

Alberto Moravia e Caterina Costantini
Lo spettacolo prende avvio immaginando un “the Day After”: un “dopo” successivo alla conclusione del testo originale dove una Rosetta, sempre più alienata da sé (interpretata da una Flavia De Stefano al suo primo e luminoso debutto), un po’ come ” il figliol prodigo”, reclama anzi tempo la sua eredità, per il capriccio di acquistare un’automobile.
La sua è l’urgenza di omologarsi a quell’italietta del tempo, preda di una “rivoluzione invisibile” di cui solo un sensibile ed altruista intellettuale come Michele riesce ad avere consapevolezza. A differenza del padre della parabola, Cesira (una carismatica Caterina Costantini, inossidabile nell’appassionarsi e nell’appassionare) si rifiuta di cedere soldi alla figlia ricorrendo ad un’ipoteca sulla loro casa: “la casa non si tocca”.
È infatti quel che resta della “roba” di cui può ancora disporre, ora che sua figlia, sfuggita all’iper protezione materna dopo il trauma della violenza subita, è ancora alla ricerca di se stessa. Lo scontro rievoca in Cesira – in una sorta di teatro nel teatro, enfatizzato da un’interessante drammaturgia della luce – una serie di ricordi e di apparizioni: ombre più o meno vaghe del suo passato.
La più vivida è quella di Michele (un fiero Vincenzo Bocciarelli) che – quasi come l’Oracolo di Delfi – la invita a riflettere sul fatto che di Rosetta lei ora raccoglie ciò che come madre è stata capace di seminare in passato: il desiderio di accumulare “roba”.

Caterina Costantini (Cesira) e Rosetta (Flavia De Stefano) in una scena dello spettacolo
Ma “seppure gli uomini muoiono – continua Michele – il dolore li fa rinascere”. E con questo invito a fare un buon uso della sofferenza per poter dare avvio ad un nuovo inizio, ad una nuova consapevolezza di sé, Michele dimostra ancora una volta di ad aver cura di lei.
Lei che resta “trincerata” – e la scena sa rendere con eloquente bellezza drammatica questo suo luogo/condizione della mente e dell’anima – dietro i suoi “valori” esistenziali basati esclusivamente sull’accumulo. Perché il primo comandamento che la guida è ancora quello che recita “l’importante è che vinca il più forte”. E di conseguenza, se non si riesce ad esserlo, si diventa complici di chi lo è.

Lorenza Guerrieri (Concetta), Caterina Costantini (Cesira) e Flavia De Stefano (Rosetta) in una scena dello spettacolo
La guerra riattizza la nostra tensione più prepotente: quella alla sopraffazione. Ma anche la mancanza di cultura educa al’insensibilità: alla divisione, all’opportunismo. “Le donne in tempo di guerra non possono andare troppo per il sottile”: a dirlo non è un uomo ma una donna (Concetta, una credibilissima Lorenza Guerrieri ), una contadina che solo in apparenza è accogliente con Cesira e sua figlia ma che all’occorrenza non ci pensa neppure un attimo a barattare la sua complicità alla vendita di Rosetta ai fascisti pur di avere liberi, cioè in “suo” potere, i suoi due figli. Perché i fascisti (qui rappresentati da un interessante interpretazione di Marco Blanchi) “c’hanno tutto: la provvidenza ce li ha mandati”.
“Che c’hai ? “. E’ questo infatti il bieco pulsare di quel che resta della coscienza. Perché in un’umanità che ha sostituito il senso della “pietà” con quello della “pietanza”, è ciò che si ha che restituisce il valore della persona. Un’umanità che parla esclusivamente di cibo da accumulare: in pancia e in quel che resta del cuore.
Per questo è importante ricordare, cioè riportare al cuore – luogo del coraggio e della concordia – in quale deriva noi esseri umani possiamo essere trascinati in tempi di guerra.
Ricordare ci dà la possibilità di consultare il passato, di interrogarlo e di interrogarci.
Per capire ed essere capaci di cura e di responsabilità nel presente e nel futuro.
Per tenere alta la consapevolezza di chi siamo, da dove veniamo e di dove abbiamo la possibilità di spingerci.

Il cast de “La Ciociara” di Aldo Reggiani
E riportare in scena questo struggente spettacolo – che si arricchisce anche delle presenze interpretative di Armando De Ceccon (nel ruolo di Filippo) e di Vincenzo Pellicanò (nel ruolo di Tommasino) – proprio in un momento storico quale quello che stiamo attraversando, lo rende estremamente prezioso.
Un necessario contributo che il Teatro non smette di rendere al vivere civile.
Recensione di Sonia Remoli