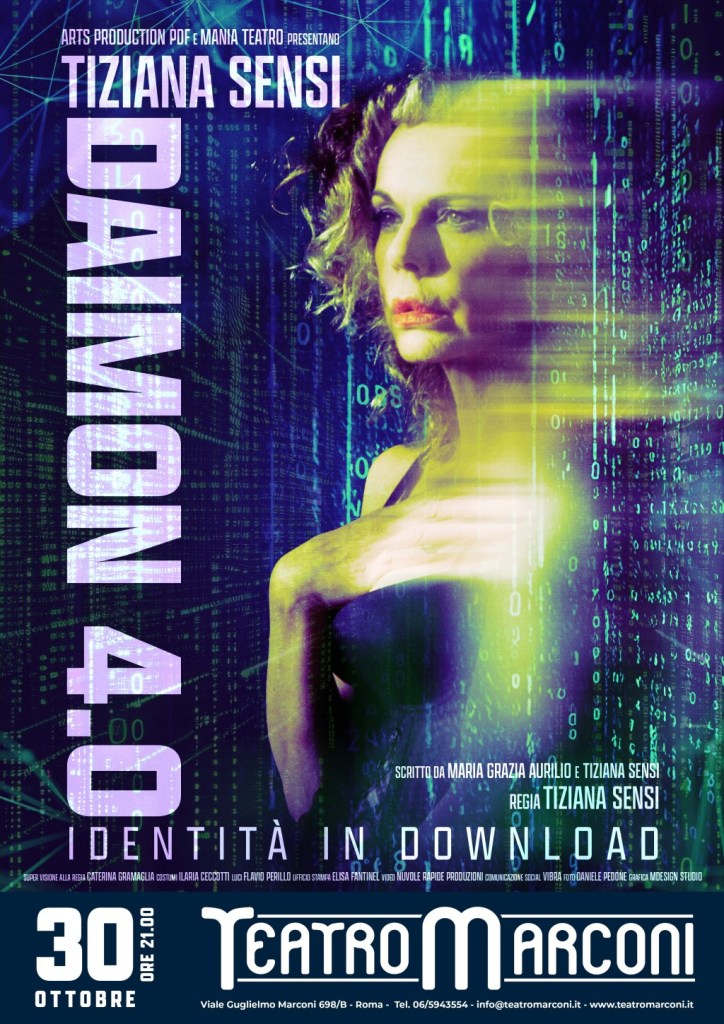TEATRO DI DOCUMENTI, dal 26 al 29 Novembre e 1° Dicembre 2024

Sono come gocce che si staccano da un liquido comune: è il brano musicale che li introduce a presentarli attraverso questa immagine.
Sono spiccatamente diversi e per questo “esclusi” dalla normalità.
Chissà perché non li definiamo invece “esclusivi”? Forse perché non siamo consapevoli che il loro sapere è precluso ai più; forse perché non riconosciamo in loro un valore prezioso. Insostituibile.

La regista Valentina Ghetti
Non c’è futuro nella separazione, nel diabolico atto dell’ escludere. È nell’inclusione, nell’integrazione, che sta il futuro: un futuro più saggio, più sacro. Al di là dei sussiegosi valori identitari.
La sofferenza – figlia della disattenzione e del non ascolto – “ha scolpito” i loro corpi e le loro menti. Ma loro sanno ancora interrogarsi: sanno chiedersi se un cambiamento sarà davvero possibile. Anche per loro, apparentemente così bloccati, così incastrati.

Si lasciano attraversare dagli stimoli previsti dagli esperimenti in programma: ma lo fanno creativamente. Paradossalmente questa loro “presentazione-esibizione” diventa l’occasione per tenere insieme le loro diversità. Non per continuare a classificarle.
E’ la parola, la prima magia di cui imparano a disporre: è il raccontarsi, tentando di tenere insieme tutto ciò che sfugge verso diverse direzioni.
Poi imparano ad ascoltarsi. Come nessuna delle loro famiglie “illustri” è riuscito a fare: loro “i figli di“, vip del mondo della cultura e della politica. Ma le loro famiglie così esclusive, li hanno inclusi nelle file degli ultimi.
Sono Eduard, il figlio di Einstein; Lucia, la figlia di James Joyce; Rosemary figlia di Joseph P. Kennedy; Giorgio figlio di Edoardo Agnelli; Albino il figlio di Benito Mussolini e Aldo il figlio di Palmiro Togliatti.
Il senso di vergogna – alimentato dai loro genitori – li ha nutriti modificando i loro caratteri fisici e psichici. Un nutrimento cesello di disagio, di condanna sociale.
Perché la vergogna è il sentire del fallimento, dell’errore privato dell’occasione del ritentare. Ancora e ancora. E’ l’inadeguatezza rispetto al proprio ruolo. È molto più dell’imbarazzo: la vergogna tocca corde profonde, identitarie.
Eduard, il figlio di Einstein (interpretato da Alessio De Persio) è un brillante musicista. Intercala i suoi racconti a delle improvvise risate, che hanno perso il confine con il pianto.
Lucia, la figlia di James Joyce (interpretata da Camilla Ferranti) è un’appassionata di danza. Indossa dei bellissimi guanti verdi, fatti di squame: ciò che resta di un abito che lei stessa si era confezionata. Per resistere.
Rosemary, figlia di Joseph P. Kennedy (interpretata da Caterina Gramaglia) è una dolcezza: ogni parte del suo corpo vive di torsioni, riccioli di grazia spettinata.
Giorgio, il figlio di Edoardo Agnelli (interpretato da Dario Masciello) è un tipo stylosissimo e fragilissimo.
Albino, il figlio di Benito Mussolini (interpretato da Leonardo Zarra) è un esperto di arti di difesa personale. La sua insicurezza lo spinge a nascondersi, continuamente.
Aldo, il figlio di Palmiro Togliatti (interpretato da Luca Di Giovanni) è un affascinante intellettuale, rigidamente solitario.
In tutti si sente che sono delle menti decisamente eccezionali. E gli interpreti in scena riescono a renderne liricamente tutta la loro insolita bellezza.
Si chiedono l’un l’altro da quale Paese vengono, loro da sempre esuli dalle loro origini.
Ma attraverso il desiderio di raccontarsi, stimolato dalle diverse occasioni sensoriali, ognuno scopre di non essere solo nella propria diversità ma anche parte di un tutto, di una comunità. “Mi ha fatto bene conoscerti” – si dicono.

L’autrice Roberta Calandra
Nelle “note di sala ” dell’autrice Roberta Calandra e della regista Valentina Ghetti si invita noi del pubblico a osservare scientificamente queste loro reazioni ai diversi stimoli. Ma è impossibile: c’è in loro una poesia che seduce e ti porta a stare “con” loro. Ed è bellissimo. E doloroso.
Mi ha fatto bene conoscervi.
Recensione di Sonia Remoli