

Richiede delicatezza, una feroce delicatezza, portare in scena l’intimità sconfinata della parola-suono di Pier Vittorio Tondelli. E una passione viscerale per la vita. Incluso il suo peggio.
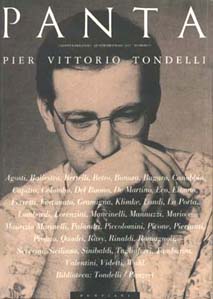
Inclinazioni vitali ben dosate in questo lavoro di Licia Lanera – che la vede attrice e regista – dove nella narrazione musicalmente postmoderna di Tondelli lei si specchia: per parlare di sè. Un raccontare e un raccontarsi, il suo, che trova e include le vite dei suoi compagni di viaggio: Giandomenico Cupaiuolo, Danilo Giuva, Roberto Magnani.

Ognuno di loro ha quel potere – ciascuno con una propria cromaticità emotiva dolce/amara e con uno stare al mondo così teneramente spietato da sconfinare nel debosciato – di far sentire lo spettatore sollevato per essere così come si è, incluse le proprie imperfezioni. Perché i quattro, di quel peggio esistenziale, ti restituiscono con onestà l’effetto che provoca su di loro. E viene facile anche per lo spettatore ritrovarsi in qualcosa.

Sono compagni di viaggio sparigliati : con quel disordine mentale biasimevole sì, ma non privo di una certa vitalità. E di un’ombra di simpatia.
Sono diversamente libertini: non si compiacciono dello strabordante tentativo di liberarsi dal conformismo, che fa spesso del loro furore una pulsione di morte.
“Siamo solo noi
Che non abbiamo vita regolare
Che non ci sappiamo limitare” – cantano.

E’ loro, il cercare di squinternare, di scompaginare, i miti della modernità.
Ma loro è anche la consapevolezza che “si è giocato troppo forte per i nostri nervi” e che si è “pagato troppo alto il prezzo per la ricerca di una nostra autenticità“. E ancora: che tutto quello fatto era lecito perché voluto, ma che si continua ad avere difficoltà con “qualche super ego malamente digerito”: misura del peso ancora attivo di certi condizionamenti sociali e provinciali.

Cercano. E non trovano calore. Imbrigliati come sono in quel “maledetto inverno” che credono di disgelare in compagnia di “una bottiglia sempre piena, finché dura il fumo”.
Anche perchè, nel cercare una loro autenticità, sono incompresi e rifiutati dal contesto sociale e politico di fine anni ‘70. Dal cui conformismo cercano di affrancarsi.

Licia Lanera li ospita. E scopre di esserne ospitata: li riconosce quali compagni del suo viaggio interiore. Abitano non solo la sua casa, ma anche la sua anima. Sono tra loro uniti, come i racconti del libro. Unità così cara a Tondelli, che li definiva capitoli di un unico romanzo.
Racconta la Lanera di questa gioventù della provincia tondelliana, ma lo fa come davanti ad uno specchio. Ed è sapiente e colmo di intima lealtà il gioco che mette in scena: lei e i suoi compagni riescono infatti a rendere così efficacemente l’essenza del testo di Tondelli anche e proprio perché (e lo spettatore lo sente) dal primo incontro lei è stata, a qualche livello, letta da questo libro.

I suoi compagni, quelli che ritrova nel libro, parlano anche di lei: la completano, le restituiscono verità sconosciute. E lo stesso riescono a fare anche con noi, che li leggiamo e ne restiamo letti.
Alle sonorità del fiume di parole con il quale così efficacemente tutti in scena rendono il flusso di coscienza tipicamente tondelliano, la Lanera sceglie di associare il controluce fumoso di una luminosità magnificamente intima. Metafora di una volontà di comunicare qualcosa, che altrimenti resterebbe celato. La drammaturgia delle luci è curata da Martin Palma.

E’, il suo, un voler portare alla luce: un processo di rivelazione, di svelamento e di scoperta.
Un tuffo e un’immersione nella luminosa oscurità di una conoscenza, precedentemente inespressa.
E poi una progressiva risalita, verso la superficie della vita quotidiana.

Risalita così ben visualizzata anche attraverso il lento rivestirsi dei tre compagni di viaggio. Il loro, un coprirsi di strati non solo di tessuto, ma anche di habiti borghesi. Traccia estetica, ma non solo, del loro essere parte di un tutto con la Lanera, quella seconda pelle color arancio – che Kandinsky definiva “un rosso avvicinato all’umanità del giallo” – cromaticamente simbolo di un’intima espansione creativa. La cura dei costumi è di Angela Tomasicchio.

Lo spazio scenico sa mantenersi in felice bilico tra reale e surreale: dove ciò che è, riesce ad alludere anche a ciò che non è. Uno spazio che restituisce – e a qualche livello lega, accogliendola – la frammentarietà del sentire di questa generazione emiliana di fine anni ‘70, che della gioventù fa uno status: un modo di stare al mondo. Come veicolato assai efficacemente anche dal brano “Sono un ribelle mamma ” (suonato dai Sunday Beens), che allude a tutta l’ambiguità di questa loro forma di ribellione. La cura del sound design è di Francesco Curci.

Uno spazio scenico – habitat vitale della Lanera – il cui centro d’attrazione è rappresentato dal darsi eroticamente creativo, di una scrivania dove – grazie anche allo specchio offerto dal libro di Tondelli – Licia Lanera trova la modalità di restituire voce a parti di sé, grazie anche alla complicità dei suoi compagni di viaggio. Parti di sè che poi confluiscono in una drammaturgia e quindi in un copione. Quello dello spettacolo, appunto. Che lei ogni volta “rivive”: dentro e fuori di sè.
Celebrando così l’essenza della libertà cercata e trovata da Tondelli: quel furore del raccontare e dell’auto raccontarsi. Manifestando, proprio attraverso il potere della parola, la lotta al conformismo.


-.-.-.-.-
Recensione di Sonia Remoli
