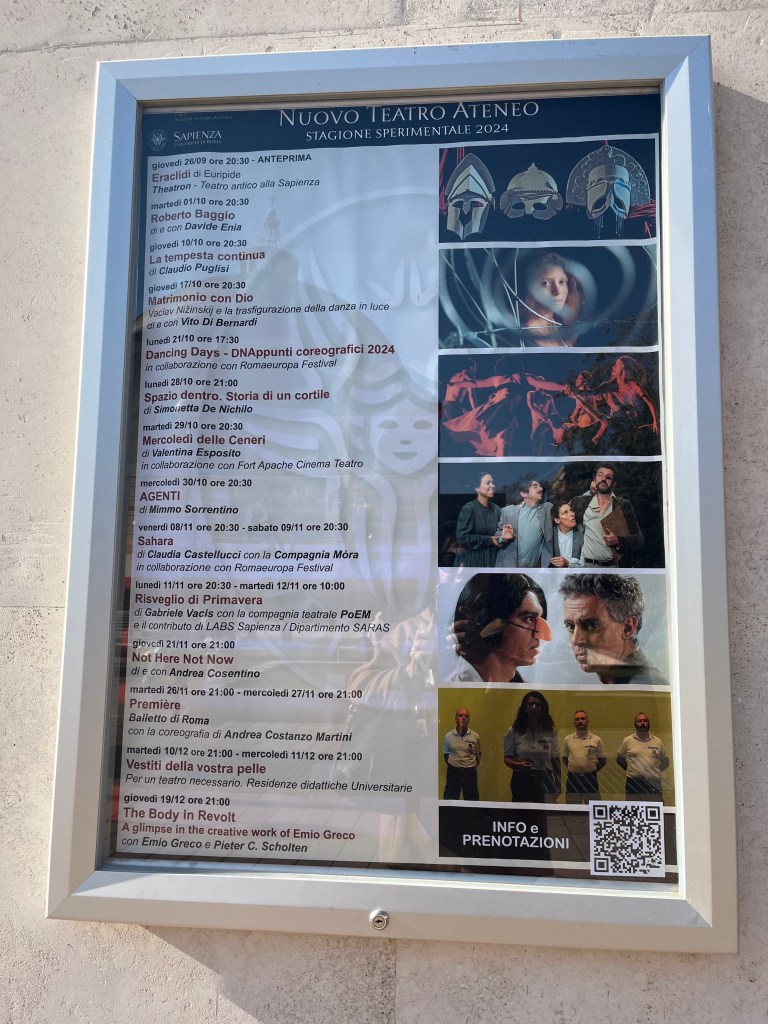traduzione e adattamento Letizia Russo
– regia Luigi Saravo –
TEATRO QUIRINO, dal 17 al 22 Dicembre 2024

Se è vero che i soldi possono condurci a perdere la percezione di noi stessi e del mondo, l’amore -ovvero quella forza generosa che tiene uniti in relazione elementi diversi – può avere la meglio sul desiderio conservativo dell’avarizia.
Questa una delle sensazioni che arrivano più pervasivamente allo spettatore, complice la traduzione e l’adattamento seducentemente calzanti alla nostra quotidianità di Letizia Russo, sinergicamente congiunti all’ avvincente sguardo registico di Luigi Saravo. Che ne cura (assieme a Lorenzo Russo Rainaldi) con efficace raffinatezza anche le scene, esaltate dalla cromoterapia luminosa di Aldo Mantovani e dal contrappunto sonoro e musicale del compositore Paolo Silvestri.
Se infatti l’avaro è colui che desidera ardentemente ma che poi non è capace di condividere né di essere generoso (e Ugo Dighero ce ne dona uno stupefacente interpretazione), il desiderare amoroso ci parla d’altro: ci parla di “quell’essere governati da quel dolce potere” che conduce quasi a dimenticare se stessi a favore della “relazione”. Ci parla di quel timore di amare troppo – perché non egoisticamente autoreferenziato, né condizionato dal giudizio degli altri – che si palesa solo fuori dalla bolla amorosa. “Quel dolce potere” di cui ci parla qui Elisa (Elisabetta Mazzullo) ma soprattutto Valerio (Fabio Barone) che, come dal primo incontro, continua a salvare dalle onde del destino la sua amata, rendendosi disponibile ad esplorare nuove identità di se stesso.
Qualcosa di ben diverso dal conquistare l’altro “compiacendolo”: un piacere relativo, non assoluto.
E non così distante dall’ambiguo piacere di condividere i nostri selfie: quell’illusione con la quale ci specchiamo, credendo di poter cogliere narcisisticamente l’attimo fuggente.
Decisamente di altra stoffa è “il trasporto all’ aver cura”: una declinazione del desiderare generoso, che nessuno qui può non notare, ad esempio, in Marianna (Rebecca Redaelli). Anche Arpagone ne rimane conquistato, ma ancora una volta solo egoisticamente.
La sua psiche è resa opportunamente da una scena che ne evidenzia i rigidi confini, attraverso mura con le quali l’Avaro delimita esternamente l’infinitezza avventurosa del bosco (metafora della vita) e internamente il sottosuolo del proprio inconscio, riducendolo ad una botola custode del suo unico desiderare conservativo monetario. Resta indifeso però l’Avaro contro l’invasione di ricorrenti allucinazioni di antichi cori “infantili” sull’ambiguo prezzo del “bene”, che lo spingono a trattenere più che ad investire. Immolandosi inconsapevolmente sull’altare del dio denaro, confuso con il “bene”.
Mobili, invece, si plasmano gli spazi in cui tentano di trovare espressione le relazioni umane (molto interessante anche il lavoro sulla prossemica). Spazi a volte resi rassicurantemente troppo limpidi, fino ad una trasparenza che esclude il rischio del con-tatto. E che tanto ci ricorda la rassicurante trasparenza dei nostri schermi tecnologici, spesso solo apparentemente differenti dalle mura di laterizi.
L’avarizia è una “maledizione” – confida Cleonte (Stefano Dilauro) a sua sorella Elisa – che va “spezzata”, disinnescata, traducendola in un desiderio personale fertile, capace cioè di generare autentici frutti, da condividere. Generosamente. Perché – come sosteneva Gilles Deleuze – non c’è niente di peggio che vivere il sogno di un altro, anziché il proprio.
I figli di Arpagone, a differenza del proprio padre, sanno che il desiderio è ossigeno vitale – e che in quanto vitale è spaesante, non rassicurante. E che si cresce solo quando le certezze acquisite vacillano: quando ciò che nel tempo ha reso forte e rigido il nostro “io” viene messo in discussione e chiede un’interpretazione critica personale.
Compiacere gli altri è più semplice: asseconda una nostra innata tensione alla conservazione protettiva. Per di più abdicare al nostro desiderio per realizzare quello di qualcuno a cui teniamo, ci rende amabili. Ma se questa tensione non viene integrata e resa produttiva restando fedeli al nostro desiderio, finiamo per inaridirci asciugando tutta la nostra linfa vitale. Non a caso Valerio dice ad Elisa che l’avarizia del padre rischia di “strangolarla”, così come sta strangolando lui stesso. Perché se è vero che la vita umana ha bisogno di “appartenenza”, è parimenti vero che ha bisogno anche di “erranza”.
Una regia – questa di Luigi Saravo su traduzione e adattamento di Letizia Russo – che trova il giusto equilibrio nel denunciare e nel farsi portavoce propositivo di una necessaria cura per la nostra “educazione sentimentale”.
Uno spettacolo che sa rendere onore alla tradizione, facendosi testimone di un sapere assimilato ma anche rielaborato con spirito critico. Tale da poter essere riproposto efficacemente in tutta la sua necessità contemporanea. Incantevole l’interpretazione di Ugo Dighero, forte della complice coralità di attori carichi di potente espressività, quali Mariangeles Torres, Fabio Barone, Stefano Dilauro, Cristian Giammarini, Paolo Li Volsi, Elisabetta Mazzullo, Rebecca Redaelli e lo stesso Luigi Saravo.
Un ”canto di Natale” che guarda anche i vuoti delle nostre esistenze: buchi nei quali si insinua una pericolosa tendenza nichilistica. E che siamo tentati, ipnotizzati dalle lusinghe di un’economia capitalistica, a riempire con “oggetti” . Che perdono assai velocemente il proprio valore, proprio per poter essere riacquistati in una nuova “versione”, più capace a renderci felici. Cioè tutti uguali. Senza personalità. Numeri di una massa indistinta, docile ad essere gestita da qualcun altro.
Ma c’è il Teatro a prendersi cura di noi: ridando valore al potere della “parola” e a quello dell’ “ascolto”. Poteri indispensabili per “realizzarci” con autentica soddisfazione: incuriosendoci a trovare di volta in volta la maniera più adeguata ad entrare “in relazione” con l’altro.
Recensione di Sonia Remoli