Drammaturgia
di Francesco d’Alfonso
liberamente tratta da “Assassinio nella cattedrale” di T.S. Eliot
Traduzione inedita
di Iolanda Pescia
TEATRO PALLADIUM
18 Dicembre 2025

Su iniziativa dell’Ufficio per la Pastorale Universitaria della diocesi di Roma, Giovedì 18 Dicembre u.s. al Teatro Palladium è andata in scena “Waiting in the dark”, una drammaturgia di Francesco d’Alfonso, liberamente tratta da “Assassinio nella cattedrale” di T. S. Eliot, nella traduzione inedita di Iolanda Plescia, docente alla Sapienza.

Francesco d’Alfonso
L’evento ha devoluto l’incasso al Polo Universitario Penitenziario – Università Roma Tre, diretto dal Prof. Giancarlo Monina, ordinario di Storia contemporanea all’Università Roma Tre e delegato del rettore per la formazione universitaria negli istituti penitenziari. “Non si tratta solo di reperire risorse – ha dichiarato – ma anche di portare all’attenzione il tema della dignità dei carcerati”.
Nel Lazio ci sono infatti 300 universitari detenuti negli istituti penitenziari presenti sul territorio, che si applicano nello studio per affrontare il periodo della prigionia con dignità. “Lo studio rinforza l’uomo interiore, colui che resta solido mentre tutto intorno a lui viene meno” – ha ricordato don Gabriele Vecchione, cappellano della Sapienza e vicedirettore dell’Ufficio diocesano per la pastorale universitaria, promotore del progetto.

(ph. Cristian Gennari)
La finalità di questo evento teatrale si dà come una manifestazione della speranza e cade non solo nel tempo del Giubileo dei Detenuti – ricorrenza che chiude circolarmente l’inizio del Giubileo della Speranza avvenuto con l’apertura della porta del Carcere di Rebibbia, quale prima Porta Santa, dopo quella di San Pietro, aperta da Papa Francesco – ma cade anche nel tempo dell’Avvento. Un tempo che simbolicamente si fa attesa spirituale e preparazione alla venuta di Cristo. Un periodo liturgico trasformativo, che unisce il ricordo della sua prima venuta (il Natale) all’anticipazione della sua seconda venuta, che si rinnova ogni anno.

“Waiting in the dark”: dall’oscurità alla luce.
Un titolo dal profondo valore simbolico: ci parla di un periodo di sospensione, che ci spinge all’introspezione e alla ricerca di una personale consapevolezza. Trasformando la paura dell’ignoto (l’oscurità) in una opportunità di crescita, di resilienza e di speranza (la luce). Dove il buio diventa spazio fertile per la nascita di nuove possibilità, purché si impari a sostarvi con amorevolezza.
E’ una condizione esistenziale che tutti ci accomuna e che T.S. Eliot ha visualizzato magnificamente, nel suo poema destinato al teatro “Assassinio nella cattedrale”, focalizzandola in un momento particolare della vita di Thomas Becket.
Per interrogarsi sulla drammaticità di un tempo esistenziale vuoto, in cui siamo messi in trazione. Come – ma non solo – è avvenuto nel frangente storico/esistenziale del Novecento, attraversato dalla Prima guerra mondiale e poi in attesa – in una pace che non è “il bacio di pace” – dentro un tempo che porterà al Secondo conflitto mondiale.
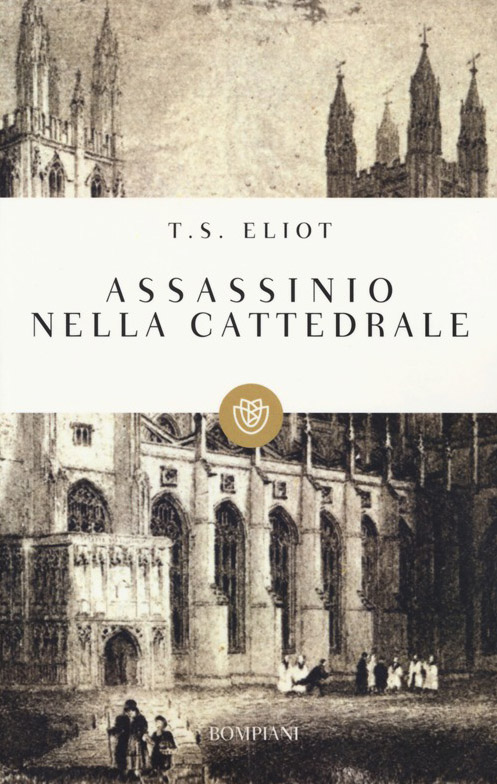
Immersa come in una landa del nostro animo, si apre allora la messa in scena di Francesco d’Alfonso. Dove lo spettatore è progressivamente condotto – come per osmosi – a scendere in una dimensione interiore: trascendente nella sua immanenza.
Non è infatti solo una rituale cerimonia d’attesa, dove si celebra un’assenza. E’ la visualizzazione di un presentimento: una condizione che si fa ponte tra inconscio e futuro e che parla di una verità intuitiva più profonda del ragionamento logico. Con un’aura di mistero, di angoscia unita a speranza.
E’ una condizione esistenziale ad andare in scena: dove la forza rappresentativa riesce a restituire epidermicamente anche ciò che non può essere detto. Quel quid che non passa per la parola.

(ph. Cristian Gennari)
Non a caso lo spazio scenico, immerso nella luminosa oscurità di un luogo sacro, è abitato da una scala: simbolo del collegamento tra dimensioni diverse. Dove l’ascesa coincide con la discesa: perché il tempo che distrugge è il tempo che conserva (da “Quattro quartetti” di T.S. Eliot).

(ph. Cristian Gennari)
Questa fluida dualità – tema portante della drammaturgia – inizia ad essere veicolata attraverso la scelta di inserire la narrazione musicale di un violino, contrappuntandola all’insistere di un ticchettio, che come goccia erode e si fa spazio nella mente e nel cuore dello spettatore.
Una fluida dualità che continua a darsi nel contrappunto tra il sentire del Coro – qui rappresentato da una Irene Ciani dolorosamente sensuale, morbidamente tagliente, magneticamente arrendevole, che con i colori morfologici della sua voce restituisce i cicli della vita, della natura e dell’animo umano – e l’invocazione ossessiva della mancanza dell’Arcivescovo di Canterbury Thomas Becket da parte del Sacerdote (in scena un efficacissimo Matteo Santinelli).
Sette anni e l’estate è trascorsa, 5 anni, da che ci lasciò l’Arcivescovo*


(ph. Cristian Gennari)
Un fluido contrasto dentro il quale il testo di Eliot fin dal principio ci invita a stare: da quando il Coro si scopre attraversato da “un restare” e insieme da un “essere trascinato da una sicurezza, che trascina i piedi”. Causa di un vago presagio che gli occhi “sono costretti a testimoniare”.
Per noi, le povere donne, non c’è l’azione
ma solo l’attendere e il rendere testimonianza*
Ed è proprio questa fluidità degli opposti a destabilizzare le donne del Coro, loro che erano abituate a riconoscere ”gli atti che mettevano un limite al nostro soffrire. Ogni orrore aveva la sua definizione, ogni dolore aveva una specie di fine” *
Una fluidità di cui ci parla anche il dualismo dal quale Thomas (uno Stefano Guerrieri tormentato e donativo, accogliente e carismatico, visione che diventa azione) si lascia attraversare come da una sorta di via crucis. Accogliendo e patendo il serpeggiante insinuarsi sensualmente vanitoso dei tentatori, nelle suadenti interpretazioni di Leonardo Della Bianca e di Stefano Poeta.


(ph. Cristian Gennari)
E ancora, è il tema dell’omelia di Becket per il Natale del 1170, ovvero la riflessione su come la ricorrenza del Natale racchiuda in sè la gioia della nascita e insieme il dolore della morte. Dolore ribadito dal fatto che, non a caso, al giorno in cui si commemora il Natale del Signore, segue il giorno in cui si commemora il Martirio di Santo Stefano.

(ph. Cristian Gennari)
E infine questo fluido dualismo è il fulcro dello stesso soffrire di Thomas Becket: a spaventarlo non è la morte ma l’intervallo tra il presagio e la fine, cioè l’attendere attraversando e trasformando.
Nè colui che agisce soffre
Nè il paziente fa. Ma sono entrambi fìssi
In un’eterna azione, in un’eterna pazienza*

(ph. Cristian Gennari)
E allora cosa significa “pace” ?
Pace è farsi strumento di questo dissidio.
E sentire
In un’eterna azione, in un’eterna pazienza
Alla quale tutti debbono consentire perché sia voluta
E che tutti debbono soffrire per poterla volere,
Onde sussista la trama, poiché la trama è azione
E sofferenza, e la ruota possa volgersi e pure
Stare per sempre immota*
(*i versi citati in questa recensione si riferiscono alla traduzione di Alberto Castelli al testo “Assasinio nella cattedrale” di T.S. Eliot)

Una rappresentazione questa di “Waiting in the dark” che ricorda quell’atmosfera di cui Eliot era maestro: quella che dona alla poesia un’energia legante, che riconcilia i suoi frammenti in un insieme emotivo.
Quell’atmosfera che si dà in un profondo senso della struttura musicale.
Complice la sinergia tra il lavoro drammaturgico di Francesco d’Alfonso e la traduzione di Iolanda Plescia, dove l’appagamento musicale si lega a quello letterario.


Recensione di Sonia Remoli





























































